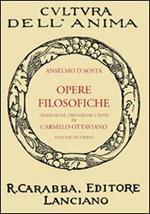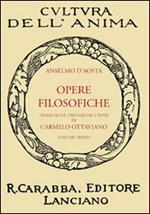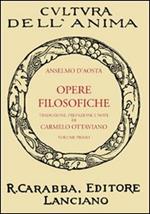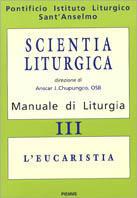Nacque ad Aosta nel 1033 o 1034 da Gundolfo, un nobile lombardo, e da Eremberga, una burgunda residente ad Aosta.
Il padre (che morì poi monaco), generoso fino alla prodigalità, riuscì poco a comprendere il suo eccezionale figliolo; assai più ebbe influenza sua madre, dama pia ed energica, che era imparentata col conte Ottone di Moriana, come ci conferma Umberto II di Aosta e Susa (cfr. Ep. 262).
A. ebbe anche una sorella Richeza, sposa di Burgundio, non meglio noto, da cui ebbe un figlio, chiamato anch'egli Anselmo, come lo zio. Questo Anselmo diventò in seguito abate di S. Saba a Roma, poi legato apostolico in Inghilterra, abate di Edmundsbury ed infine vescovo di Londra. Di altri parenti materni conosciamo i nomi, come i due zii Folcheraldo e Lamberto e i due cugini Folcheraldo e Pietro.
Non ancora quindicenne, A. pregò un abate ch'egli conosceva di accoglierlo nel suo monastero, ma ne ebbe un rifiuto, mancando il consenso del padre, e non fu accettato neppur quando, per ciò, s'ammalò gravemente. Mortagli poi la madre, si diede a vita mondana e dissipata, senza tuttavia abbandonarsi a gravi eccessi.
Quando, però, la tensione dei suoi rapporti col padre divenne intollerabile, A. lasciò la casa paterna e la patria recandosi, per il valico del Moncenisio, in Francia e in Borgogna, ove rimase tre anni.
Intorno al 1059, A. giunse all'abbazia di Bec, in Normandia, allo scopo di conoscerne il priore, Lanfranco di Pavia, la cui fama richiamava alunni da tutte le parti d'Europa. Anche A. si fece discepolo di Lanfranco e ne divenne molto presto coadiutore nell'insegnamento. Ripreso dal desiderio di farsi anch'egli monaco, ebbe qualche esitazione circa il monastero da scegliere, poi, seguendo il consiglio dell'arcivescovo Maurilio di Rouen, entrò proprio a Bec, ove ben presto fu un magnifico esempio per quei religiosi. Dopo soli tre anni, quando Lanfranco divenne abate di Santo Stefano di Caen, A. gli subentrò nella carica di priore e nel 1078, morto l'abate di Bec (un ex cavaliere Herluin, uomo di grande semplicità, ma anche di estrema intelligenza, che aveva fondato Bec con il suo danaro), A. fu eletto abate all'unanimità.
Nell'adempimento dei doveri della sua carica egli disponeva di qualità eccezionali: era un maestro nella conoscenza e nel trattamento delle anime. Non era, forse, una prova delle sue qualità pedagogiche il fatto che il giovane priore sapesse trasformare in amici anche quelli dei suoi confratelli che prima avevano sentito invidia di lui? Tra costoro c'era, soprattutto, un tale Osberno, un giovane monaco estremamente dotato, ma di carattere un po' difficile. A. nei suoi riguardi, in un primo tempo, dimostrò grande indulgenza, per diventare gradualmente più severo, fino a che il giovane non si rese conto, delle nobili intenzioni del suo maestro e gli si sottomise spontaneamente. Alla morte inattesa di Osberno, A. fu colto da profondo dolore, dedicandogli per un anno la Messa. Nel trattamento dei monaci, egli non era eccessivamente severo; anzi, pur di conservare un'atmosfera amorevole, mise alquanto da parte la severità della regola. Dai consigli da lui elargiti a un abate, che, nonostante le frustate, non riusciva a mantenere la disciplina tra allievi, ci risulta che egli fu un pedagogo nel senso moderno della parola.
A. preferiva istruire i giovani già maturi, perché riteneva che quella fosse l'età più indicata per la formazione dei caratteri. L'insegnamento delle materie elementari non gli si addiceva troppo. Amava, invece, discutere con i suoi monaci di problemi filosofici e teologici, riuscendo a dare impostazioni inconsuete a tali problemi e a trovare soluzioni originalissime. Profondamente ancorato alla fede, non temeva - come dice il suo biografo Eadmero - di usare la ragione anche nell'applicazione ai misteri della fede. Da queste discussioni e, soprattutto, dai suoi solitari studi notturni nacquero i suoi scritti, alla cui stesura lo indusse l'affettuosa insistenza dei suoi discepoli e di altri, tra cui l'arcivescovo Ugo di Lione. Già la sua prima opera, il Monologion ,manifestò l'altezza della sua mente. Poco dopo nacque il celebre Proslogion, che doveva la sua origine ad una intuizione filosofica. Appartengono al periodo di Bec anche i quattro dialoghi De grammatico, De veritate, De libertate arbitrii e De casu diaboli.
L'abilità di A. e la sua profonda pietà contribuirono ad attrarre numerosi giovani a Bec. Egli non si stancava di affermare oralmente e per iscritto la superiorità della vita monastica rispetto a quella secolare. Era suo principio non insistere perché proprio Bec fosse scelto come luogo della conversatio,ma poté pur dire: "Quasi tutti voi siete venuti a Bec per causa mia". Quanto i suoi monaci si sentissero legati a lui lo prova la tenacia con cui gli rifiutarono il permesso di lasciarli.
Il fascino della sua personalità si riflette nelle sue lettere, testimonianza di uno spirito delicato e affettuoso. L'attrazione che sapeva esercitare anche su persone di condizione non religiosa si rivelò nel comportamento del re Guglielmo il Conquistatore. Il re era normalmente un individuo cupo, ma alla presenza di A. si trasformava completamente, diventando mite e dolce. Sul letto di morte lo fece chiamare al suo capezzale, ma A., ammalato, non potè presentarsi in tempo.
Diventato abate, A. affidò immediatamente ad altri monaci i compiti di carattere amministrativo - che pure avrebbe saputo assolvere egregiamente -, per potersi dedicare completamente alla cura delle anime e alla formazione spirituale delle persone affidategli. Gli interessi della sua abbazia lo obbligarono, tuttavia, a compiere vari viaggi: alcuni sul continente, quando ancora era priore, al posto dell'abate ormai diventato vecchio, altri in Inghilterra, dove Bec aveva possedimenti, quando egli era già abate. Fu perciò in Inghilterra poco dopo tempo la sua elezione ad abate e vi rivide il suo venerato maestro Lanfranco, diventato nel 1070 arcivescovo di Canterbury. In Inghilterra Anselmo conobbe anche il giovane Eadmero, suo futuro biografo. Fu un viaggio trionfale, poiché la sua fama di geniale maestro era giunta nell'isola. Qui, come sul continente, dovunque giungesse, gli abati lo invitarono a parlare nel capitolo dinanzi ai loro monaci: di questi discorsi ci è giunto in particolare quello, celebre, tenuto a Cluny sulla beatitudine celeste. Originale ora, soprattutto, il suo metodo d'insegnamento: egli sapeva adattarsi a tutti gli ascoltatori, sia monaci, sia chierici, sia laici, destandone l'attenzione con esempi tratti dalla vita. In tal modo A. trascorse trentatré anni tra i suoi monaci, un periodo ch'egli stesso definì felicissimo e fecondo.
Ma un improvviso mutamento strappò A. a questa felice attività. Nel 1089 Lanfranco era morto in Inghilterra: il dispotico Guglielmo II Rufo, che, nel 1087, era succeduto a suo padre, perseguiva una politica ecclesiastica arbitraria ed egoistica, specialmente dopo la morte di Lanfranco, la cui autorità aveva rispettato. Così, per esempio, lasciò vacante la cattedra di Canterbury e altri benefici per incamerarne le entrate relative. Per non alimentare le dicerie circa una eventuale sua candidatura come successore di Lanfranco, l'abate di Bec rifiutò a lungo di accettare un invito del conte Ugo di Chester, che avrebbe voluto ottenere un insediamento di monaci al posto dei canonici. Dovette infine acconsentire, sia perché il conte era stato colpito da una grave malattia, sia perché gli interessi dell'abbazia richiedevano la sua presenza in Inghilterra. Vi giunse il 7 dic. 1092. Durante la riunione natalizia della corte, i grandi del regno costrinsero il re a concedere loro il permesso di far recitare preghiere in tutte le chiese del Regno, per ottenere un nuovo pastore. Il re, tuttavia, considerava inutili simili preghiere, non avendo egli alcuna intenzione di nominare arcivescovo A. o chiunque altro. Ma ecco che, improvvisamente, una grave malattia colpì il sovrano. Tutti ritennero imminente la sua morte; i principi ed i vescovi accorsero per ammonirlo a pensare alla salute dell'anima. Il re volle allora confessarsi ad A., si pentì sinceramente ed emanò un editto d'amnistia. Era ormai anche disposto a far occupare il seggio di Canterbury e la sua scelta cadde proprio su A., il quale rifiutò ostinatamente di accettare la nomina. Quando si vide che a nulla servivano tutti gli incitamenti da parte del re e dei vescovi, gli fu posta tra le mani a forza la bacchetta con cui il re gli aveva conferito l'investitura e venne trascinato alla chiesa più vicina per la celebrazione del rito, senza che nessuno desse ascolto alle sue continue proteste. (Tale scena è stata riferita dettagliatamente non solo da Eadmero, ma dallo stesso Anselmo). A., più tardi, dichiarò nullo l'accaduto, spiegando che quelli che avevano così agito con lui volevano accoppiare ad un solo aratro un agnello e un toro indomito. Né egli poteva in alcun modo essere utile alla Chiesa d'Inghilterra. Tutto ciò ebbe luogo il 4 marzo 1093. Parecchio tempo passò fino all'accettazione definitiva della nomina. Il re, pentitosi del proprio pentimento, ritirò il decreto d'amnistia e infierì peggio di prima, ma non revocò la nomina di Anselmo. Questi, da parte sua, ne subordinò l'accettazione a varie condizioni: anzitutto, il re avrebbe dovuto restituire i beni tolti all'arcivescovado, accettare lo stesso A. come consigliere in tutti i problemi di carattere spirituale e, infine, riconoscere Urbano II come papa legittimo. Il re acconsentì a tutte queste condizioni. Arrivarono intanto i documenti del duca di Normandia e dell'arcivescovo di Rouen, nei quali costoro accettavano le dimissioni di A. da abate, nonché il consenso della maggior parte dei monaci di Bec. Quindi Rufo gli conferì in feudo l'arcivescovado. Il 25 settembre, tra il giubilo di tutti, A. venne insediato a Canterbury ed il 4 dicembre ebbe luogo la sua consacrazione a vescovo da parte di Tommaso, arcivescovo di York.
La riluttanza di A. ad assumere la dignità arcivescovile con i benefici feudali, che le erano annessi, va compresa ed inquadrata nella difficile situazione della Chiesa d'Inghilterra dopo la conquista normanna.
Guglielmo il Conquistatore infatti ed i suoi successori avevano esteso ai territori da loro occupati la politica ecclesiastica, già attuata nei domini aviti, per cui vescovi, abati, ed ecclesiastici in genere, venivano nominati dal signore ed erano tenuti ad obbedire indipendentemente da ogni decisione dei loro superiori ecclesiastici e persino della Curia romana.
Contro questa politica, perseguita con decisione e costanza, poco o nulla aveva potuto l'opera di riforma della Chiesa sia in Normandia sia in Inghilterra. E di ciò s'era reso perfettamente consapevole A. durante la sua attività di abate a Bec. Da parte sua A., per la sua formazione spirituale e culturale, aveva risolutamente abbracciato gli ideali della "libertas ecclesiae" dal potere laico.
Non è dunque strano che per A. abbia avuto inizio un lungo calvario. Il primo conflitto con il re si ebbe alla corte di Natale, nella quale fu decisa la guerra contro la Normandia: si suggerì allora all'arcivescovo di offrire 500 sterline d'argento come contributo alla guerra. Il re, sobillato dai suoi consiglieri, rifiutò tale somma, giudicandola troppo esigua, e chiese il doppio. A., a sua volta, respinse tale richiesta e regalò ai poveri il denaro rifiutato. In febbraio egli fu convocato a Hastings per benedire gli eserciti in partenza per la Normandia. Poiché, a causa dei venti contrari, la partenza fu rimandata di un mese, egli si servì di questo tempo per fare al sovrano proposte per una riforma dei costumi, suggerendo la convocazione di un concilio di vescovi ed esigendo che il re insediasse abati nelle abbazie vacanti, per eliminare il disordine che vi regnava. Il re, senza il cui consenso non era possibile né un concilio, né una riforma, rifiutò tutto. Il vescovo fu congedato anzi tempo e cadde in disgrazia, essendosi egli nuovamente rifiutato di dare il denaro richiesto. Guglielmo Rufo ritornò poi in Inghilterra alla fine dell'anno senza aver concluso nulla. In quell'anno (1094), A. terminò l'Epistola de incarnatione Verbi, dedicandola a Urbano II.
Nel febbraio dell'anno successivo (1095) A. informò il sovrano che intendeva recarsi a, Roma, dal papa, per ottenere il pallio. Il re gli negò il consenso al viaggio, non avendo egli ancora riconosciuto Urbano II come papa. A. gli ricordò la promessa fattagli e chiese di poter convocare un concilio di vescovi, abati, e principi, che avrebbero dovuto stabilire se egli fosse in condizione di conciliare la sua ubbidienza verso la Santa Sede con la fedeltà al re. Il re accettò la proposta: si ebbe così il celebre concilio nazionale di Rockingham, dall'11 al 14 marzo.
Lo svolgimento del concilio ci è stato riferito dettagliatamente da Eadmero, testimone oculare: l'arcivescovo espose la questione agli intervenuti, vescovi, principi e popolo, chiedendo il consiglio dei vescovi. Questi gli suggerirono di lasciare esclusivamente al re la decisione, solo in tal caso lo avrebbero appoggiato, dichiarandosi, però, disposti a riferire il discorso di A. al sovrano. Questi differì la seduta definitiva alla giornata seguente, ma anche in quella giornata i vescovi dettero lo stesso consiglio. A. dichiarò loro intanto che egli si sarebbe attenuto al consiglio di Dio, il quale aveva detto non a principi laici, bensì a San Pietro e ai suoi successori: "Tu es Petrus". Poi ripeté il detto di Gesù: "Date a Cesare quel che è di Cesare". Ne nacque un'enorme confusione e un grande tumulto. I vescovi si rifiutarono di riferire simili parole al re; A., allora, si recò da lui in persona. Il sovrano, adiratissimo, si consigliò con i Grandi del Regno e, ancora una volta, gli fece dire che obbedisse a lui e che non seguisse più gli ordini di Urbano. Ma A. rifiutò energicamente; e dette una risposta che confuse i suoi oppositori, facendo capire che un arcivescovo di Canterbury poteva essere giudicato soltanto dal pontefice. Il popolo, che fino a quel momento era stato intimorito, ora mostrò apertamente la propria simpatia per l'arcivescovo. Il giorno successivo, il portavoce dei vescovi, l'ambizioso Guglielmo di Durham, propose di usare la violenza, dato che non esisteva alcun appiglio legale contro l'arcivescovo; ma gli si opposero i principi laici. Il re, irritato con i vescovi a causa degli insuccessi avuti, li invitò a rifiutarsi di obbedire ad A. e di considerarlo come fratello; egli stesso gli avrebbe negato ogni sicurezza e non l'avrebbe più riconosciuto come padre spirituale. I principi secolari presero allora partito per A., dichiarando che essi avrebbero continuato a considerarlo come loro padre spirituale e arcivescovo. Tale atteggiamento riempì di mortificazione i vescovi. A., convinto che un'attività proficua in quelle condizioni fosse impossibile, chiese il salvacondotto fino a un porto per poter lasciare il paese. Il re fu estremamente confuso da tale richiesta, non desiderando assumersi l'impopolarità che un simile esilio gli avrebbe procurato. Si consigliò, quindi, con i suoi principi secolari, che gli suggerirono di proporre una tregua fino all'ottavo giorno dopo Pentecoste. A. conciliante accettò, pur sicuro che la misura non avrebbe portato ad una soluzione del problema.
Senza dubbio, Rockingham rappresenta una vittoria morale di Anselmo. Roberto di Melun disse al re: "Mentre noi trascorriamo le giornate a tessere piani, l'arcivescovo dorme, e poi annienta le nostre trame con una sola parola".
Ben presto il re tentò una nuova manovra contro Anselmo. Di nascosto mandò a Roma due chierici di corte, Gerardo (futuro arcivescovo di York) e Guglielmo Warelwast, perché accertassero chi fosse il papa legittimo e gli chiedessero il pallio, nell'intento di espellere A. dall'Inghilterra e conferire l'arcivescovado e il pallio ad un altro. Effettivamente, poco prima di Pentecoste, si presentò in Inghilterra il cardinale-vescovo di Albano, Gualtiero, insieme con i due chierici, e si recò a visitare il re, trascurando l'arcivescovo. Guglielmo Rufo, convinto che il legato del pontefice lo avrebbe contentato in tutto, riconobbe Urbano ufficialmente come papa. Quando, però, pretese da Gualtiero la deposizione di A., il legato gli fece capire che ciò sarebbe stato impossibile. Alla fine della tregua, A. fu convocato a corte, a Windsor. Un ulteriore tentativo dei vescovi di acquistare il favore del re mediante denaro fallì completamente: A. pretese un'assoluta libertà d'azione come vescovo, o un salvacondotto per poter visitare il papa. Dietro consiglio dei principi, il re accolse benevolmente A., che rifiutò, però, di accettare il pallio dalle mani del sovrano. Venne allora deciso che lo avrebbe accettato dall'altare di San Pietro a Canterbury e che se lo sarebbe imposto da solo, come avvenne in forma solennissima il 6 giugno 1095.
Seguì un periodo più tranquillo. Quando Guglielmo Rufo prese la Normandia in amministrazione da suo fratello Roberto, partito come crociato, e dovette pagare l'ingente somma di 10.000 marchi, A. contribuì anch'egli per una parte. All'inizio del 1097, il re trovò un nuovo pretesto per procedere contro Anselmo. Dopo il ritorno dalla campagna contro il Galles, lo accusò per iscritto di avere male equipaggiato i soldati da lui forniti e minacciò di convocarlo davanti ad un tribunale. A. non degnò di una risposta il re, ma gli chiese di nuovo di permettergli di fare un viaggio a Roma, per sbrigare alcuni affari urgenti. Dopo lunghe trattative, il re, a Winchester, decise che A. sarebbe potuto partire, senza, tuttavia, portare nulla con sé e con l'obbligo di essere al porto entro dieci giorni. L'arcivescovo diede al re la sua benedizione e si congedò (15 ott. 1097); ma, prima della partenza, dové subire una perquisizione dei bagagli, ordinata dal re alla ricerca di denari. Non appena A. ebbe lasciato il territorio inglese, Rufo riprese possesso dell'arcivescovado e dichiarò nulle le disposizioni di Anselmo.
Durante il viaggio a Roma, A. si fermò a lungo presso il suo amico, l'arcivescovo Ugo di Lione, il quale, d'ora in poi, sarà il suo principale consigliere. I seguaci, infatti, dell'antipapa avevano reso pericoloso il proseguimento del viaggio. In una lettera A. espose la situazione ad Urbano e lo pregò di dargli un consiglio. Urbano rispose invitandolo a venire subito a Roma, ove fu accolto con tutti gli onori e ospitato per dieci giorni nel Palazzo Lateranense. Il papa scrisse a Guglielmo e lo sollecitò a restituire l'arcivescovado ad Anselmo. Questi, intanto, aveva accettato l'invito di un ex monaco di Bec, l'abate Giovanni di Telese, a trascorrere i caldi mesi estivi a Sclavia, nella sua residenza estiva. Qui, nella solitudine dei monti, A. portò a termine la sua opera più importante (che egli aveva già iniziato in Inghilterra), il Cur deus homo. Roberto, duca di Puglia, che stava assediando Capua, invitò il celebre arcivescovo e lo avrebbe voluto trattenere sempre presso di sé. Anche i Saraceni rimasero profondamente colpiti dalla personalità di Anselmo. Pessime notizie venivano, intanto, dall'Inghilterra. Quando anche il papa giunse a Capua, A. lo pregò di voler accettare le sue dimissioni: era convinto di non poter essere utile sotto un re come Guglielmo Rufo. Urbano non volle, però, acconsentire ed invitò, invece, A. a partecipare al concilio di Bari, indetto per il 1º ott. 1098, ove sarebbe stata discussa anche la sua questione.
A Bari l'arcivescovo di Canterbury assunse inaspettatamente un ruolo assai importante. Si discuteva della processione dello Spirito Santo dal Figlio, processione che veniva negata dai delegati greci. Urbano, il quale aveva già ricavato i suoi argomenti da un'opera di A., il De incarnatione Verbi, improvvisamente invitò l'arcivescovo a volergli venire in aiuto. A., il giorno successivo, parlò su questo tema in modo da stupire tutti i presenti. Quando il discorso cadde sul re d'Inghilterra, tutti i vescovi ne condannarono il comportamento e ne richiesero la scomunica, specialmente in considerazione del fatto che il re già in precedenza si era dimostrato insensibile agli ammonimenti del pontefice. Allora A. intervenne e chiese che si soprassedesse per la decisione. Dopo il concilio, A. accompagnò il papa a Roma, ove dopo qualche tempo apparve Guglielmo Warelwast, per sostenere la causa del suo sovrano. Il pontefice minacciò allora di scomunicare il re durante il sinodo di Pasqua, a meno che non avesse ridato ad A. l'arcivescovado. Ma il re seppe procurarsi amici a Roma, anche mediante la corruzione, e ottenne un rinvio fino alla festa di San Michele (29 settembre). A., quindi, giudicò inutile un ulteriore soggiorno a Roma e volle partire per Lione, ma Urbano lo trattenne fino al sinodo di Pasqua (iniziato il 24 aprile 1099). Durante quel sinodo fu rinnovata la scomunica contro tutti coloro che avessero concesso o ricevuto l'investitura laica di chiese, o consacrato gli investiti, nonché contro tutti coloro che diventassero feudatari di laici per uffici ecclesiastici. La partecipazione di A. a questo sinodo avrà conseguenze gravissime. Al termine del sinodo, A. lasciò Roma e si recò a Lione, ove aiutò l'arcivescovo nelle sue funzioni pastorali e ottenne, come dappertutto, l'amore del popolo. Vi scrisse anche l'opera annunziata nel Cur deus homo, il De conceptu virginali et de originali peccato e la Meditatio redemptionis humanae.
Urbano morì in luglio, prima che gli fosse giunta una risposta del re d'Inghilterra. Questi si sentì trionfante e decise di non preoccuparsi affatto del nuovo pontefice. Il suo trionfo non fu, però, di lunga durata: il 2 agosto dell'amo successivo (1100), una freccia lo colpì a morte durante una partita di caccia.
Ora A. fu richiamato in Inghilterra dai suoi monaci, nonché dal nuovo re Enrico I, e vi giunse il 23 settembre, accolto dal giubilo del paese. Il re, in un primo tempo, era animato dalle migliori intenzioni: si scusò con lui di non aver potuto attendere per l'incoronazione fino al suo arrivo (era, infatti, compito dell'arcivescovo di Canterbury incoronare il re d'Inghilterra). Quando, tuttavia, secondo la consuetudine, si volle che A. accettasse l'arcivescovado dalle mani del re e gli prestasse il giuramento di vassallaggio, egli si rifiutò di farlo tra lo stupore di tutti, richiamandosi al divieto del sinodo romano al quale aveva partecipato. Lasciò al re l'altemativa di rinunciare all'investitura o di costringerlo ad abbandonare il paese: disse, infatti, che non gli sarebbe stato permesso avere rapporti con gli scomunícati, e che, dati i suoi legami con la corte, non sarebbe stato possibile evitare ogni relazione con costoro. Il re venne così a trovarsi nella più grande perplessità: da una parte, riteneva di non poter rinunciare all'investitura e al giuramento di vassallaggio; dall'altra, aveva bisogno dell'influenza di A. per consolidare il proprio potere, minacciato dal duca di Normandia, reduce ormai dalla crociata. Fu così deciso di rinviare la decisione fino a Pasqua, perché ambo le parti potessero mandare ambasciatori al papa Pasquale II, per ottenere la dispensa dal divieto d'investitura. A., che, nell'attesa, s'era insediato nel proprio arcivescovado, ebbe una parte di rilievo nei preliminari delle nozze del re con Matilde, figlia del re di Scozia, Malcom III: s'era, infatti, dovuto accertare in un concilio che non era monaca, come era sembrato. Perciò, anche dopo le nozze, celebrate il 10 nov. 1100, la regina, grata ad A., rimase con lui in rispettosissima corrispondenza. Poi, non essendo tornati da Roma a tempo i messaggeri, fu necessario procrastinare fino a dopo Pentecoste il proseguimento delle trattative. Prima di quel termine, improvvisamente, Roberto di Normandia apparve in Inghilterra con un esercito per impadronirsi della corona. Una gran parte dei principi era disposta a schierarsi dalla sua parte; si dovette solo alla influenza di A. se Enrico non perdette il trono e Roberto lasciò l'Inghilterra a suo fratello minore senza combattere. I legati intanto erano tornati da Roma, senza aver nulla ottenuto: il nuovo pontefice insisteva nel divieto dell'investitura da parte dei laici. Il re era adirato con A. per essersi questi di nuovo rifiutato di rendergli l'omaggio; ma, dopo qualche tempo, volle rappacificarsi con l'arcivescovo e si mise d'accordo con lui per inviare una nuova, più importante missione presso il pontefice. Per A. partirono Baldovino di Bec e Alessandro di Canterbury, per il re tre vescovi, capeggiati dall'arcivescovo Gerardo di York, uomo di grande levatura mentale, ma privo di carattere, il quale voleva contemporaneamente ottenere il pallio. Ma anche questa missione fallì, perché i legati ritornarono di nuovo con una risposta negativa. Ciononostante, Enrico pretese che A. non rinunciasse ulteriormente alle vecchie consuetudini. Questi accennò all'epistola papale, il cui contenuto il re non aveva ancora divulgato. Ed ecco che avvenne qualcosa di strano: i vescovi, che erano tornati da Roma, dichiararono che il papa avrebbe loro detto in udienza segreta di voler concedere ad Enrico il diritto d'investitura, a condizione, tuttavia, che l'investitura stessa fosse conferita soltanto ad uomini degni. Precisarono che il tenore delle lettere ufficiali era diverso, perché gli altri principi non vi trovassero un appiglio per pretendere anch'essi un simile privilegio; ma Baldovino negò energicamente questa affermazione dei vescovi, causando una grande perplessità. Alla fine, però, si credette più al giuramento dei tre vescovi che non alle affermazioni dei monaci e alle lettere sigillate del pontefice; A. fu invitato a pronunciare il giuramento d'omaggio e a consacrare i vescovi designati. Egli volle, però, ricevere prima istruzioni chiare da Roma; rifiutò, quindi, di consacrare i vescovi e proibì anche che altri li consacrasse, ma, nel frattempo, non volle allontanarli dalla sua comunione. Nell'agoato 1102, a Londra fu celebrato un concilio di tutti i vescovi e di tutti gli abati, durante il quale vari abati furono deposti per simonia o per altri reati; il concilio inoltre emanò una serie di canoni per sacerdoti e laici e minacciò di gravi sanzioni i colpevoli di sodomia. Continuando A. a rifiutarsi di procedere alla consacrazione dei vescovi, l'incarico ne fu dato a Gerardo di York; la consacrazione, tuttavia, non ebbe luogo perché i nominati, improvvisamente, si ritirarono pentiti. Nella quaresima del 1103 il re riprese ad angustiare A.: questi si riferì alle lettere del pontefice, che non erano ancora state aperte e che Enrico si rifiutò di aprire. Il re allora suggerì ad A. di recarsi in persona a Roma, per ottenere la dispensa desiderata. Poiché anche i grandi lo spingevano a tale viaggio, il 27 aprile A. abbandonò senz'altro l'Inghilterra. Nel timore di doversi incontrare con gli scomunicati, qualora la lettera del pontefice contenesse una scomunica, egli nonvolle aprirla se nona Bec. La lettera, effettivamente, colpiva di scomunica chiunque si fosse macchiato di peccati collegati alla investitura da parte dei laici; da essa risultava chiaro il mendacio dei tre vescovi.
Temendo il caldo estivo di Roma, A. rimase a Bec fino alla metà di agosto. Quando, finalmente, giunse a Roma, era stato preceduto da Guglielmo, Warelwast, il quale, tuttavia, nulla d'essenziale aveva ottenuto. Nella discussione decisiva sulla questione il pontefice insisté nel proprio rifiuto. Al ritorno da Roma, A. si fermò a Lione per celebrarvi il Natale; lì lo raggiunse Guglielmo, che da parte del re gli comunicò la seguente ambasciata: "Se in tutte le cose tu agirai come i tuoi predecessori hanno agito con i miei predecessori, il tuo ritorno mi è il benvenuto". A. interpretò tale frase nel senso che, in caso diverso, il suo ritorno non sarebbe stato gradito, e si fermò a Lione, dove rimase per un anno e quattro mesi e dove scrisse il De processione spiritus sancti.
Durante il concilio lateranense del marzo 1105 Pasquale scomunicò i vescovi investiti dal re. Il sovrano era eccettuato dalla scomunica, perché il pontefice si aspettava ancora un messaggio da lui. Quando A. si rese conto che non avrebbe potuto ottenere un aiuto efficace da Roma, partì per la Normandia, dove il re soggiornava, per scomunicarlo a sua volta. Durante il viaggio visitò la sorella di Enrico, la contessa Adala di Blois, per assisterla in una grave malattia. Questa, però, quando venne a sapere dell'imminente scomunica di suo fratello, intervenne, riuscendo ad ottenere un incontro tra il re e l'arcivescovo a l'Aigle (2 luglio 1105). E poiché il re voleva evitare le conseguenze della scomunica, si giunse ad un accordo: fu così sospeso il sequestro delle entrare di Canterbury. Tuttavia A. non volle ritornare in Inghilterra, perché il re continuava ad avere rapporti con i vescovi da lui investiti. Nel frattempo proseguivano gli sforzi per ottenere una soluzione definitiva delle questioni ancora in sospeso col pontefice. Soltanto dopo lunghi rinvii, voluti dal re e lamentati da A., Guglielmo Warelwast e Baldovino furono infine in grado di iniziare la loro missione. Intanto nuove gravi angherie finanziarie furono imposte all'Inghilterra a causa di una nuova campagna nella Normandia. Tra l'altro il re inflisse punizioni pecuniarie ai sacerdoti incontinenti, ma anche a quelli innocenti, tanto che l'arcivescovo dovette protestare contro questa ingerenza del re nei diritti della Chiesa. Ora perfino i vescovi si rivolsero al loro primate, supplicandolo di voler rientrare in Inghilterra, per far cessare questi abusi. Tornarono, intanto, i legati con una missiva papale del 23 marzo 1106, con la quale fu concesso ad A., fra l'altro, di assolvere dalla censura tutti coloro che fossero stati investiti e consacrati da laici e avessero fatto il giuramento di vassallaggio. A. stesso fu autorizzato, a richiesta del re, a riprendere le relazioni con i tre vescovi che avevano calunniato il pontefice. Gli fu anche ingiunto di assolvere il re e la regina dai loro peccati, per cui Enrico fece pregare l'arcivescovo di ritornare in Inghilterra; ma bisognò attendere poiché A. era impedito da varie malattie. Il re allora visitò il 15 agosto A. a Bec, e tra i due fu raggiunta una riconciliazione; il re restituì tutte le chiese, tutte le entrate confiscate e indennizzò i sacerdoti puniti.
A. poté allora tornare in Inghilterra, do ve ebbe accoglienze trionfali. Il 1 ag. 1107 ebbe luogo una riunione di vescovi e di principi, nel corso della quale furono pubblicamente regolati tutti gli affari ecclesiastici. Il re annunciò che in avvenire nessun vescovo o abate sarebbe stato investito con l'anello e il pastorale da lui o da un altro laico. A., invece, concesse che non sarebbe stata negata la consacrazione a nessuno che avesse pronunciato il giuramento di vassallaggio al re. Questa soluzione di compromesso pose termine alla lunga lotta per l'investitura in Inghilterra. Il re occupò allora tutte le sedi vescovili e le abbazie vacanti, ed A. consacrò solennemente a Canterbury tutti i vescovi di nuova nomina. Purtroppo i successi che A. aveva acquisito con tanta tenacia e tanto spirito di sacrificio nel campo della politica ecclesiastica non furono duraturi. Occorse il sangue del successore di A., del martire san Tommaso Becket, per assicurare la "libertas ecclesiae" in Inghilterra. Il contegno coraggioso di Anselmo infuse, tuttavia, uno spirito nuovo d'indipendenza di fronte al dispotismo regio nel clero servile e anche nel popolo.
A. impiegò gli ultimi anni della sua vita per migliorare le condizioni della Chiesa. Né bisogna dimenticare gli sforzi da lui compiuti per sollevare il livello morale dell'Irlanda e dei paesi dell'estremo nord, che si trovavano sotto la sua giurisdizione ecclesiastica. Un grande dolore gli arrecò la lotta con York, per la primazia in Inghilterra. Il nuovo arcivescovo di York - del resto, ammiratore personale di A. - si vide ostacolato dal suo clero a pronunciare il consueto giuramento di sottomissione a Canterbury. A., dal canto suo, era invece deciso a non cedere ad alcun costo un diritto della sua chiesa. La spiacevole controversia poté essere risolta a favore di Canterbury soltanto dopo la morte di Anselmo. Durante questi anni A. volle ancora portare a termine la sua opera De Concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae Dei cum libero arbitrio. La morte, che lo colse il mercoledì santo 21 aprile del 1109, gli impedì di scrivere un trattato sull'origine dell'anima. Ebbe sepoltura accanto al maestro e predecessore Lanfranco, nella cattedrale.
Durante le lotte religiose ai tempi di Enrico VIII, le ossa del santo furono esumate insieme con altre, tanto che non si conosce attualmente il luogo dell'inumazione di Anselmo.
A. ebbe fama di santo quando era ancora in vita. La sua canonizzazione fu iniziata da Tommaso Becket e compiuta da Alessandro III nell'anno 1163. Nel 1720 Clemente XI lo dichiarò dottore della Chiesa. Senza dubbio Anselmo è una delle personalità spiritualmente più significative e più nobili del Medioevo, vivo ancora nelle sue opere.
Le opere di Anselmo sono conservate in un'eccellente tradizione manoscritta, mentre acritiche, finora, erano le edizioni a stampa.
La "editio princeps", uscita a Norimberga nel 1491 per i tipi di Hochfeder, era assai manchevole. Anche l'edizione dei frati maurini a cura di G. Gerberon, Parigi 1675 (ristampa presso Migne, Patrologia Latina, t. 158 e 159), l'edizione cioè che fino a ieri era considerata fondamentale, mostra gravi lacune. Essa è stata ora sostituita dalla edizione di F. S. Schmitt (S. Anselmi Opera Omnia, Edinburgi 1946 ss.), di cui finora sono usciti 5 volumi con il testo completo delle opere e delle lettere e con gli Indici. Sono autentiche le opere e lettere contenute in questi volumi (e soltanto esse). Sono stati eliminati tutti gli opuscoli di carattere ascetico, ad eccezione di 19 preghiere e 3 meditazioni. Le Lettere, che finora erano raccolte in 4 volumi, ora sono comprese soltanto in 2 (lettere del periodo di Bec e di Canterbury) e hanno una numerazione continua. Le opere e le lettere hanno un ordine cronologico, ad eccezione delle preghiere, le quali seguono un ordine a soggetto, secondo l'antichissima tradizione stabilita dallo stesso Anselmo.
Si danno ora, in ordine cronologico, le indicazioni fondamentali relative alle opere di A. ed al loro contenuto:
1) Il Monologion, che in precedenza aveva avuto il titolo Exemplum meditandi de ratione fidei, è una teodicea concentrata in 80 brevi capitoli. Vi si dimostra, anzitutto, l'esistenza di un sommo bene, dedotta dai numerosi beni di questa terra. Similmente si deduce che deve esistere un solo Essere Altissimo e - data l'esistenza di vari gradi di perfezione - perfettissimo. Questo Essere altissimo e perfettissimo è soltanto per sé stesso e da sé stesso - tutte le altre cose esistenti sono state create da lui dal nulla; seguono poi gli attributi di questo Essere Sommo. L'autore passa successivamente all'esame del Verbo, attraverso il quale Dio esprime sé stesso ed in cui tutto il resto è Vita e Verità. Il Verbo procede da chi lo ha generato: tale rapporto tra Padre e Figlio è trattato dettagliatamente. Il reciproco Amore tra Padre e Figlio può essere chiamato lo Spirito del Padre e del Figlio. Quindi l'autore discute i rapporti tra questi Tre, che possono essere designati come persone, oppure, secondo l'uso greco, come sostanze. Infine la Trinità è considerata come oggetto della conoscenza, dell'amore e della beatitudine, della speranza e della fede della creatura ragionante. Soltanto nell'ultimo capitolo è detto che tale Essere Sommo, Uno e Trino è chiamato Dio.
Per comprendere A. è di somma importanza poter seguire il metodo con cui egli si avvicina ai problemi del Monologion.L'autore si propone di arrivare per mezzo della sola ragione (sola ratione)a tutto ciò che riteniamo necessario di Dio e dei suoi attributi. Egli non tiene conto, intenzionalmente, dell'autorità della Sacra Scrittura, allo scopo di convincere mediante questo procedimento puramente razionale anche i non credenti. L'essenza intima del suo metodo è dunque apologetica. Lanfranco, richiesto da Anselmo di esprimere un giudizio su questa sua prima opera, criticò il sistema e disse che avrebbe preferito una maggior considerazione delle autorità.
2) Il Proslogion (con la discussione relativa) è un breve scritto, già intitolato Fides quaerens intellectum, prima che con i titoli Monologion e Proslogion si potessero stabilire gli esatti rapporti che intercorrono tra le due opere. Secondo le intenzioni di A., avrebbe dovuto rappresentare una semplificazione e, fino ad un certo punto, una sostituzione del Monologion. Al posto, infatti, delle numerose e complicate dimostrazioni di quest'altra opera, l'autore presenta un unico argomento. Nella prefazione dello scritto ci racconta in quale modo giungesse a questa scoperta. Egli parte dal concetto di Dio assunto dalla Fede ("credimus") come qualcosa di cui non si può immaginare nulla di più grande ("id quod maius cogitari nequit") e deduce da questo concetto la necessità della sua esistenza anche extramentale. Le sue argomentazioni sono queste: ci si può immaginare che quella cosa, oltre la quale non si può pensare nulla di più grande, debba esistere non solo nella ragione, ma anche nella realtà che è cosa più grande; così deve esistere anche nella realtà; altrimenti non ci sarebbe qualcosa oltre la quale non ci si può immaginare nulla di più grande. L'argomento è poi applicato alla dimostrazione dell'essenza e degli attributi di Dio.
Anche questa prova ha finalità apologetiche, in quanto si rivolge a chi nega Iddio. Non appena gli verrà proposto il concetto "ciò, di cui non si può pensare nulla di più grande", l'ateo non potrà negarne l'esistenza anche fuori della mente. Per quanto il concetto venga preso dalla fede, se ne traggono argomentazioni puramente razionali; e nell'ambito della dimostrazione non ha più nessuna importanza, donde il concetto provenga.
L'interpretazione di K. Barth, per la quale quest'unico punto, ricavato dalla fede, dell'esistenza di Dio, punto che momentaneamente rimane in sospeso, verrebbe ricavato dai restanti dati di fede, è diametralmente opposta alle intenzioni di Anselmo.
L'argomentazione del Proslogion è stata chiusa da A. nella cornice di una Oratio per cui aveva già foggiato una sua forma letteraria propria. Da questo intreccio di speculazione e preghiera (l'unica volta che questo si verifica presso A.) nasce una magnifica opera d'arte, modellata probabilmente sulle Confessiones di s. Agostino.
È poi errato voler ricavare da questa forma letteraria di preghiera indirizzata a Dio la conclusione che nel Proslogion non si possa trattare affatto di una dimostrazione dell'esistenza di Dio (come sostiene invece A. Stolz).
L'argomentazione del Proslogion trovò presto un critico ad A. sconosciuto, il cui nome, però, Gaunilone di Marmoutiers, risultò poi da due manoscritti francesi del secolo XII. Questi scrisse un'obiezione al Proslogion, e A. gli rispose con una replica, che volle poi rimanesse per sempre allegata alla sua opera. Del resto, anche san Tommaso d'Aquino e dopo di lui molti altri ancora, obiettarono ad A. le stesse cose che aveva obiettato Gaunilone, e cioè che la dimostrazione introdotta nel Proslogion contenesse un salto non lecito dall'ordine logico a quello ontologico (quindi a partire da Kant la prova di A. venne chiamata "prova ontologica dell'esistenza di Dio"). Si poteva giungere alla sicurezza dell'esistenza di un essere così perfetto, soltanto presupponendo che un tale essere esistesse davvero. D'altra parte, la dimostrazione ha avuto anche entusiastici consensi, come quelli di s. Bonaventura, Duns Scoto, Cartesio, Leibnitz e altri ancora, che hanno più o meno modificato la prova anselmiana. Ancora oggi perdura il dissenso sull'argomento; a mio parere, tuttavia, i testi difficilmente ammettono un'interpretazione che non sia quella aprioristica.
3) Il De grammatico, primo dei quattro dialoghi successivi tra maestro e scolaro, è definito dallo stesso autore come non inutile per chi voglia essere introdotto nella dialettica. Con acume logico questo dialogo - che ricorda i dialoghi di Platone (C. Ottaviano) - si serve della questione se grammaticus sia una sostanza o una qualità per spiegare una serie di concetti logici, per la cui soluzione si adopera più volte Aristotele.
4) L'importante scritto De veritate tratta del concetto della verità e delle sue diverse applicazioni nella lingua parlata. La verità stessa culmina poi nella Somma Verità. Alla originalissima definizione della verità come "rectitudo sola mente perceptibilis" si affianca quella della giustizia come "rectitudo voluntatis servata propter ipsam rectitudinem".
5) Il De libertate arbitrii contrappone alla definizione agostiniana del libero arbitrio come "posse peccare aut non peccare", una propria: "potestas servandi rectitudinem, voluntatis propter ipsam rectitudinem". Dimostra, tra l'altro, che l'angelo e l'uomo non l'hanno perduto nemmeno dopo il peccato; che esso continua anche nella tentazione; che Dio stesso non può allontanare nessuno dalla rectitudo voluntatis. Alla fine segue una ripartizione distintiva della libertà.
6) Il De casu diaboli, un lavoro assai ricco di contenuto dal punto di vista teologico, investiga il problema di come l'angelo sia diventato colpevole per la sua caduta, non essendo egli dotato della grazia della perseveranza. A. si dilunga su importanti questioni, tra cui per esempio sul problema dell'essenza della libertà, del male e della causalità del male da parte di Dio, della potenza, della conoscenza che l'angelo ha in precedenza della propria caduta, dell'impossibilità per l'angelo caduto di ritornare alla giustizia, ecc.
7) La Epistola de incarnatione verbi fuprovocata da una lettera di Giovanni, suo monaco a Bec e futuro abate di Telese, sul detto triteistico del celebre nominalista Roscellino: "Si in Deo tres personae sunt, una tanturn res unaquaeque per se separatim, sicut tres angeli aut tres animae, ita tamen, ut voluntate et potentia omnino sint idem: ergo pater et spiritus sanctus cum filio est incarnatus". A., che non disponeva di ulteriori informazioni, aveva iniziato la sua confutazione quando ancora era abate (questa prima redazione fu scoperta contemporaneamente da Wilmart e da Sclimitt). L'aveva poi interrotta dopo l'abiura di Roscellino al concilio di Soissons, terminandola poi, da arcivescovo, quando Roscellino era riapparso in pubblico con la sua eresia. Lo scritto era dedicato al papa Urbano II. Anche qui A. trae i propri argomenti dalla sola ragione, dato che il suo antagonista non crede alla Sacra Scrittura e non la interpreta esattamente. Lo scritto è essenzialmente una dottrina della Trinità, ma contiene anche brani importanti per la filosofia (problema degli universali); nella introduzione reca alcuni chiarimenti notevoli sulla relazione tra fede e ragione, da cui risulta chiaramente che A., nonostante il suo metodo razionale, era ben lontano da un razionalismo non cristiano.
8) Il Cur Deus homo, l'opera principale di A., è di grande importanza per la dottrina della Redenzione nella teologia cattolica. Questo delizioso dialogo con Bosone (suo futuro secondo successore come abate di Bec) è diretto contro la vecchia teoria ripresa da Origene e mantenutasi fino al Medioevo inoltrato, per cui il demonio, a causa della caduta dei progenitori avrebbe ottenuto un diritto su tutto il genere umano. La Redenzione era avvenuta perché il Diavolo aveva perduto i suoi diritti sull'uomo quando aveva voluto ingiustamente impadronirsi della persona immune dal peccato del Dio-Uomo. A. sostituì a questa dottrina un nuovo tentativo di spiegazione, dopo d'aver provato l'assurdità della teoria che il demonio possa avere diritto sul genere umano: è la cosiddetta teoria della soddisfazione.
Il peccato è un'infinita offesa di Dio. Condonarlo senz'altro sarebbe contrario alla giustizia divina. Così resta soltanto la pena o la soddisfazione. L'uomo doveva soddisfare, ma Dio solo poteva soddisfare; era quindi necessario che un Uomo-Dio desse soddisfazione, se non doveva andar delusa l'intenzione divina con l'uomo, da lui chiamato alla beatitudine.
Nel corso della dimostrazione sono incluse una serie di digressioni, per esempio sul numero degli angeli caduti che dovranno essere sostituiti dagli uomini, sulla spontaneità della morte di Cristo ecc. La teologia successiva ha essenzialmente accettato la dottrina di A. sulla Redenzione.
Anche qui abbiamo un'elaborazione accuratissima del metodo seguito dall'autore. Il Cur deus homo è un lavoro eminentemente apologetico. In esso A. discute con gli infedeli (nel senso più vasto della parola); contemporaneamente però vuol confortare i fedeli mediante l'analisi e l'approfondimento di quanto essi credono. Quindi, anche qui si procede in maniera puramente razionale: si parte metodicamente dal presupposto che Cristo non sia ancora apparso, e viene messa in evidenza la necessità (rationes necessariae) che tutto si debba compiere come poi effettivamente si compì. La teologia, tuttavia, non lo ha seguito nel mettere in rilievo questa necessità.
9) Il De conceptu virginali et de originali peccato, opera estremamente feconda per la teologia, si propone di portare un'ulteriore motivazione della questione già trattata nel Cur deus homo, per quale ragione cioè Cristo, pur provenendo dalla massa damnatrix, sia rimasto immune dal peccato originale. In proposito l'autore tratta una serie di argomenti importanti, tra cui la natura del peccato originale, il grado della sua gravità, il modo come esso ci fu trasmesso dai progenitori, la convenienza che Cristo nascesse da una vergine, l'influenza dei peccati personali dei genitori sui figli, la dannazione dei bimbi morti senza battesimo, ecc. Qui, A. ha anche stabilito il principio della necessità che la Madonna, dopo Dio, fosse l'essere più santo. "Decens erat, ut ea puritate, qua maior sub deo nequit intelligi, virgo illa niteret cui deus pater unicum filium suum... ita dare disponebat, ut naturaliter esset unus idem comunis dei patris et virginis filius etc." appianando così la strada alla teologia verso il concetto dell'Immacolata Concezione, un concetto che egli stesso non accetta (cfr. Cur deus homo e De conceptu virginali).
10) Il De processione spiritus sancti, uno scritto che si distingue particolarmente per acume dialettico, è una rielaborazione dell'orazione tenuta da A. al concilio di Bari sulla processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. È il primo scritto e allo stesso tempo anche lo scritto conclusivo contro l'eresia greca. Dato che i Greci accettano la Sacra Scrittura, anche A. si vuol basare su di essa. Nel motivare il dogma, egli fu il primo a stabilire questo principio per la Trinità: "Omnia sunt unum, ubi non obviat relationis oppositio" (cfr. Decretum pro Iacobitis: Denziger, Enchiridion n. 703).
11) Nel De sacrificio azimi et fermentati, una risposta a questioni del vescovo Walramo di Naumburg il quale propendeva verso lo scisma, mostra in primo luogo che la giustificazione dei latini di servirsi del pane azimo per il sacrificio della Messa era almeno altrettanto valida quanto quella dei greci di servirsi del pane fermentato. Quindi A. difende anche il numero moderato dei gradi di parentela fra consanguinei dei latini rispetto a quello esagerato dei greci.
12) La Epistola de sacramentis ecclesiae, diretta al medesimo vescovo, espone la giustificazione delle differenze negli usi liturgici secondari presso i greci e i latini.
13) Il De concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae dei cum libero arbitrio, l'ultimo scritto di A., tratta in tre sezioni i difficili problemi menzionati nel titolo, problemi che lo avevano già a suo tempo preoccupato a Bec. In esso, accanto alla parte speculativa, cerca anche di far armonizzare i brani della Sacra Scrittura in apparente contraddizione tra loro. Importanti anche nella terza parte alcune osservazioni di principio a proposito della Sacra Scrittura.
14) Preghiere e Meditazioni. Nel prologo l'autore stesso dà istruzioni per la lettura e lo studio di queste preghiere che si distinguono enormemente da altri opuscoli ascetici della sua epoca. Anzitutto, per la forma artistica (si tratta di veri piccoli capolavori retorici, con uso abbondante di figure oratorie, soprattutto del costante parallelismo dei periodi), poi per la razionalità del metodo e il brillante svolgimento del tema. La loro sensibilità soggettiva le avvicina alla forma moderna d'ascetismo. Di particolare importanza è la terza "Orazione a Maria", per la sua straordinaria bellezza, e soprattutto per il suo ricco contenuto mariologico. Si può dire che in tutta la letteratura religiosa non esista nulla di simile. Nella prima parte della Meditatio redemptionis humanae (Med. 3) l'autore dà un riassunto del Cur deus homo, ma alleggerito degli sviluppi polemici, metodologici e apologetici.
15) Le Lettere di A. in numero di 475,con lettere indirizzate a lui e ad altri, ci offrono un quadro vivace del suo carattere e della sua visione ascetica del mondo. Le lettere di data più recente sono importantissime per la storia ecclesiastica dell'Inghilterra dei suoi tempi. A. era in corrispondenza con uomini di tutti i ceti che sapessero scrivere: con monaci e monache, con abati, vescovi e altri ecclesiastici, con signori dell'aristocrazia e con altre personalità secolari, con donne di alto lignaggio, ecc. Ricordiamo alcuni nomi celebri: Gregorio VII, i re Filippo e Ludovico di Francia, Alessandro di Scozia, Muriardach d'Irlanda, Baldovino di Gerusalemme, i conti Roberto di Fiandra, Harco delle Orcadi, le contesse Matilde di Toscana, Alta di Blois, Ida di Boulogne-sur-Mer, Adele e Clemenza di Fiandra, i vescovi Ivo di Chartres, Ildebrando di Le Mans, Astero di Lund, Diaco di Santiago, l'abate Ugo di Cluny.
Appendice:I Dicta Anselmi sono appunti di conferenze tenuti da Anselmo. Sono stati trovati in singoli manoscritti, specialmente nel cod. 457della Biblioteca del Corpus-Christi College di Cambridge, ma non sono scritti dalla sua mano. Il loro autore è il monaco Alessandro, menzionato sopra come un messo di Anselmo. Essi formano il nucleo dell'opera De similitudinibus, una compilazione posteriore, falsamente attribuita ad Eadmero. (L'edizione dei Dicta è in corso di preparazione).
Al di là degli originali contributi alla soluzione dei singoli problemi teologici risultanti dall'esame degli scritti, l'opera di A. acquista un particolare significato nella storia del pensiero medievale soprattutto per il compito assegnato alla ratio e alla dialettica nell'approfondimento della speculazione dogmatica.
Contro la presunzione dei "dialettici moderni", che rischiavano di subordinare la fede alle regole del discorso logico-dialettico, ma anche contro la negazione tradizionalistica della ratio in nome della auctoritas, A. difende - e realizza nei suoi scritti - il peculiare ed ineliminabile compito della ratio per enucleare tutta la ricchezza del patrimonio dogmatico accettato dal credente per semplice fede. "Fides quaerens intellectum" è il titolo originario del Proslogion e riassume l'orientamento della speculazione di A.: "non tento Domine penetrare altitudinem tuam, quia nullatenus comparo illi intellectum meum; sed desidero aliquatenus intelligere veritatem tuam, quam credit et amat cor meum. Neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam. Nam et hoc credo: quia nisi credidero, non intelligam" (Proslogion, 1 ed. Schmitt, vol. I, p. 100); la fede è la fondamentale esperienza su cui si esercita la speculazione razionale: "qui non crediderit, non intelliget. Nam qui non crediderit, non experietur; et qui expertus non fuerit, non cognoscet" (Epistola de incarnatione Verbi, I;e d. cit., vol. II, p. 9).
Muovendo dalla fede, l'intellectus progressivamente scopre la ratio immanente alla fede (ratio fidei), svolgendosi senza piu bisogno di ricorrere all'auctoritas che resta oggetto, non mezzo di prova; in questo processo l'intelligere raggiungeuna sua necessitas (rationes necessariae) nella misura in cui riesce a scoprire quella assoluta ratio veritatis che presiede all'economia della rivelazione e fonda la ratio fidei,come la ragione dell'uomo (ratio veritatis nos docuit).
Si definisce in questo contesto il valore dell'intellectus, teso fra fede e visione beatifica: "Certa enim fides - aveva scritto Agostino - utcumque inchoat cognitionem, cognitio vero certa non perficietur, nisi post hanc vitam, cum videbimus facie ad faciem" (De Trinitate, 9, I, I; P. L. 42, 961); sulla stessa linea di pensiero A. scrive: "inter fidem et speciem intellectum, quem in hac vita capimus esse medium, intelligo" (Cur Deus homo, lettera dedicatoria; ed. cit. vol. II, p. 40). La speculazione razionale è in continuazione della fede e avvia a quella comprensione dei misteri divini che si compirà solo nella visione beatifica; è il pregnante sviluppo del versetto paolino "videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum" (I Cor.13, 12).
Per intendere la posizione anselmiana sarebbe quindi erroneo muovere da una giustapposizione tra fede e ragione: esse sono situate sulla stessa linea di sviluppo come momenti di unico conoscere, dalla fede alla contemplazione; di qui anche il nesso tra speculazione e preghiera, che è caratteristica dell'opera anselmiana: fervore religioso e tensione speculativa sono così saldamente congiunti che reciprocamente si rafforzano, sicché dove più profondo è il mistero della fede, più impegnata si fa anche la ratio:caratteristica l'indagine sul mistero dell'Incarnazione.
Le interpretazioni "razionalistiche" del pensiero anselmiano - che si appoggiano sul valore delle rationes necessariae nel discorso teologico - non tengono conto dell'immanenza della ratio nella fede e presuppongono un'idea di "ragione naturale" a lui estranea. D'altra parte, la definizione dell'opera di A. come esclusivamente "teologica" può essere accettata solo se si tiene presente che nel suo pensiero - come nell'età sua - non v'è distinzione tra filosofia, e teologia quali discipline estranee o giustapposte, ma l'una e l'altra agostinianamente si risolvono nella ricerca e nel godimento del vero e del bene (sapientia), cioè di Dio: e poiché Egli stesso ha rivelato agli uomini la via della verità, non avrebbe senso una ricerca della sapienza che volesse prescindere dalla fede nella sua rivelazione.
Racconta il biografo di A., Eadmero, che ancora sul letto di morte l'arcivescovo di Canterbury si tormentava attorno al problema filosofico dell'origine dell'anima: è questo costante impegno speculativo che ha meritato ad A. il titolo di Padre della scolastica; infatti se egli restò lontano dall'impostazione "sistematica" delle più tarde "summae" - la sua opera si svolge per monografie separate - la posizione che egli riconobbe alla ratio nell'elaborazione speculativa del dogma segna il consapevole inizio di quel processo che - attraverso l'opera dei sommisti e canonisti del XII secolo e soprattutto di Abelardo - porterà nel secolo XIII, arricchito delle tecniche della logica aristotelica, alla teorizzazione della teologia come "scienza".
Fonte: Dizionario biografico dell'Enciclopedia Treccani