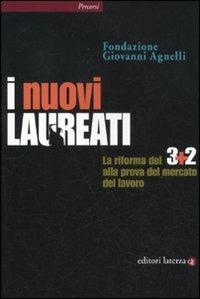L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
I nuovi laureati. La riforma del 3+2 alla prova del mercato del lavoro
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti
Altre offerte vendute e spedite dai nostri venditori

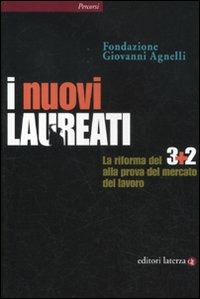
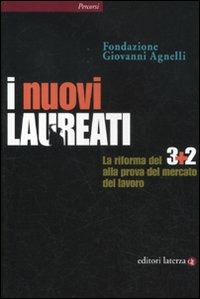
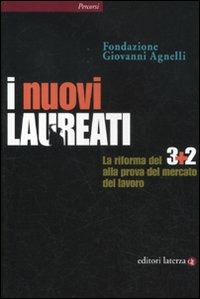
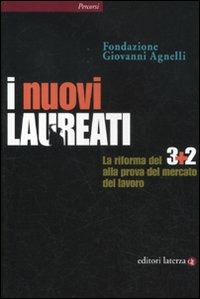
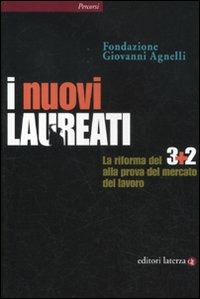
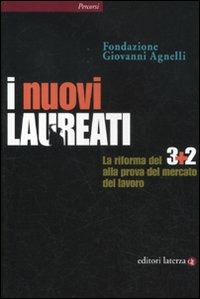
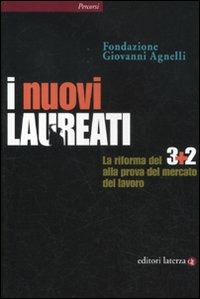
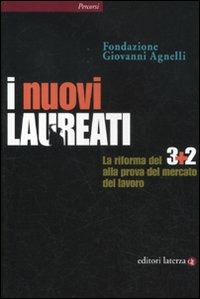
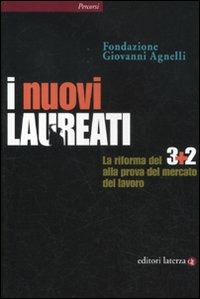
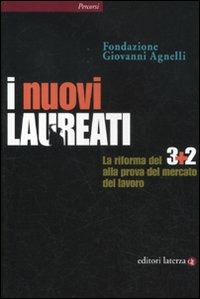
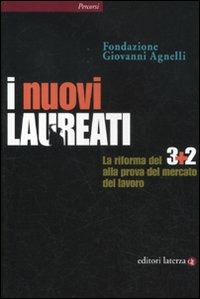
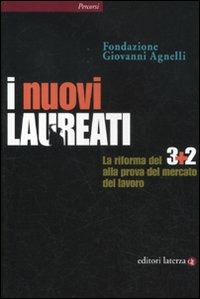
Il 2000 segna un'importante cesura nella storia recente dell'università italiana. In quell'anno viene introdotta, infatti, la riforma del "3+2". Nata dalla volontà di adeguare l'organizzazione dell'offerta universitaria al modello prevalente di istruzione superiore europea, strutturato su due livelli principali di studio - laurea triennale (bachelor) e laurea magistrale (master) - la riforma si propone di superare il grave ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi avanzati in termini di capitale umano. E, insieme, di rispondere a una domanda di equità e di mobilità sociale. Aumentare il numero di iscritti e di laureati, rendendo più veloce il conseguimento del titolo di studio, significa - nell'intenzione del legislatore - offrire ai giovani di origine sociale svantaggiata reali opportunità di accesso e di successo all'istruzione superiore, offrendo una preparazione che consenta loro un inserimento rapido e remunerativo nel mercato del lavoro dell'economia della conoscenza. Chi sono e quale profilo hanno i nuovi laureati post-riforma? In che cosa si distinguono dai loro predecessori e dagli attuali diplomati? Che giudizio si può dare del loro percorso lavorativo - per quanto ancora breve - in termini di occupazione e retribuzione? La formazione ricevuta è adeguata alle esigenze del mercato e serve alla modernizzazione del sistema economico italiano?

L'articolo è stato aggiunto al carrello
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da IBS, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.ibs.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare complianceDSA@feltrinelli.it
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
Siamo spiacenti si è verificato un errore imprevisto, la preghiamo di riprovare.
Verrai avvisato via email sulle novità di Nome Autore