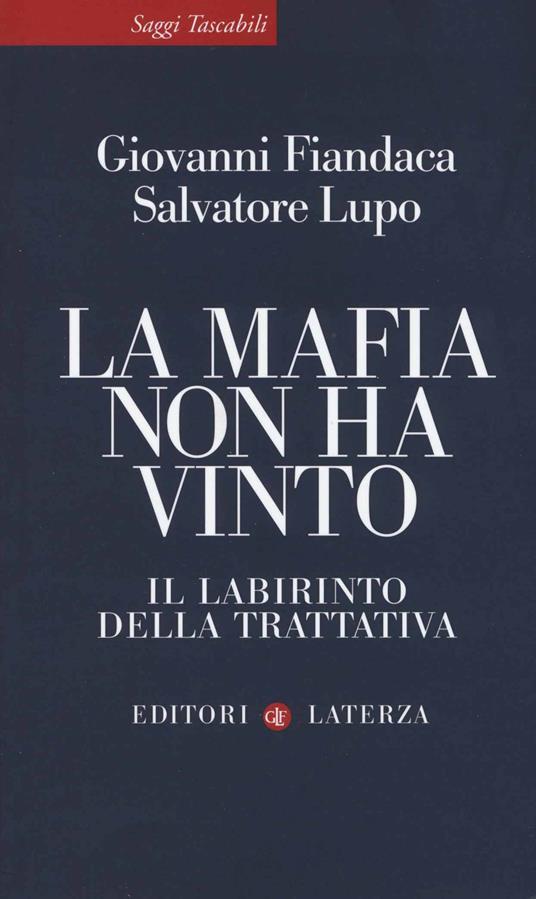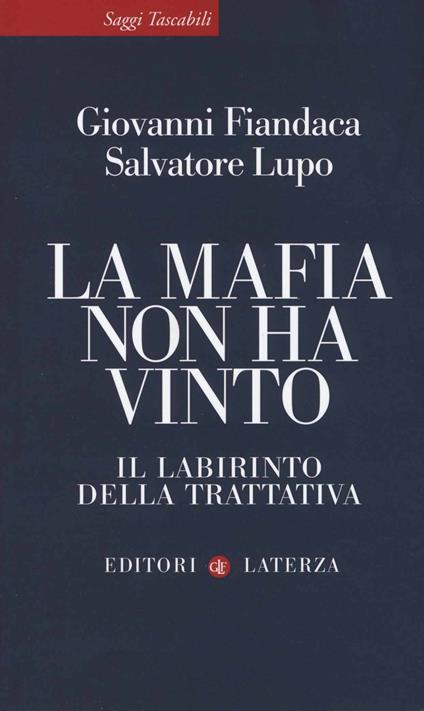L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti
Altre offerte vendute e spedite dai nostri venditori

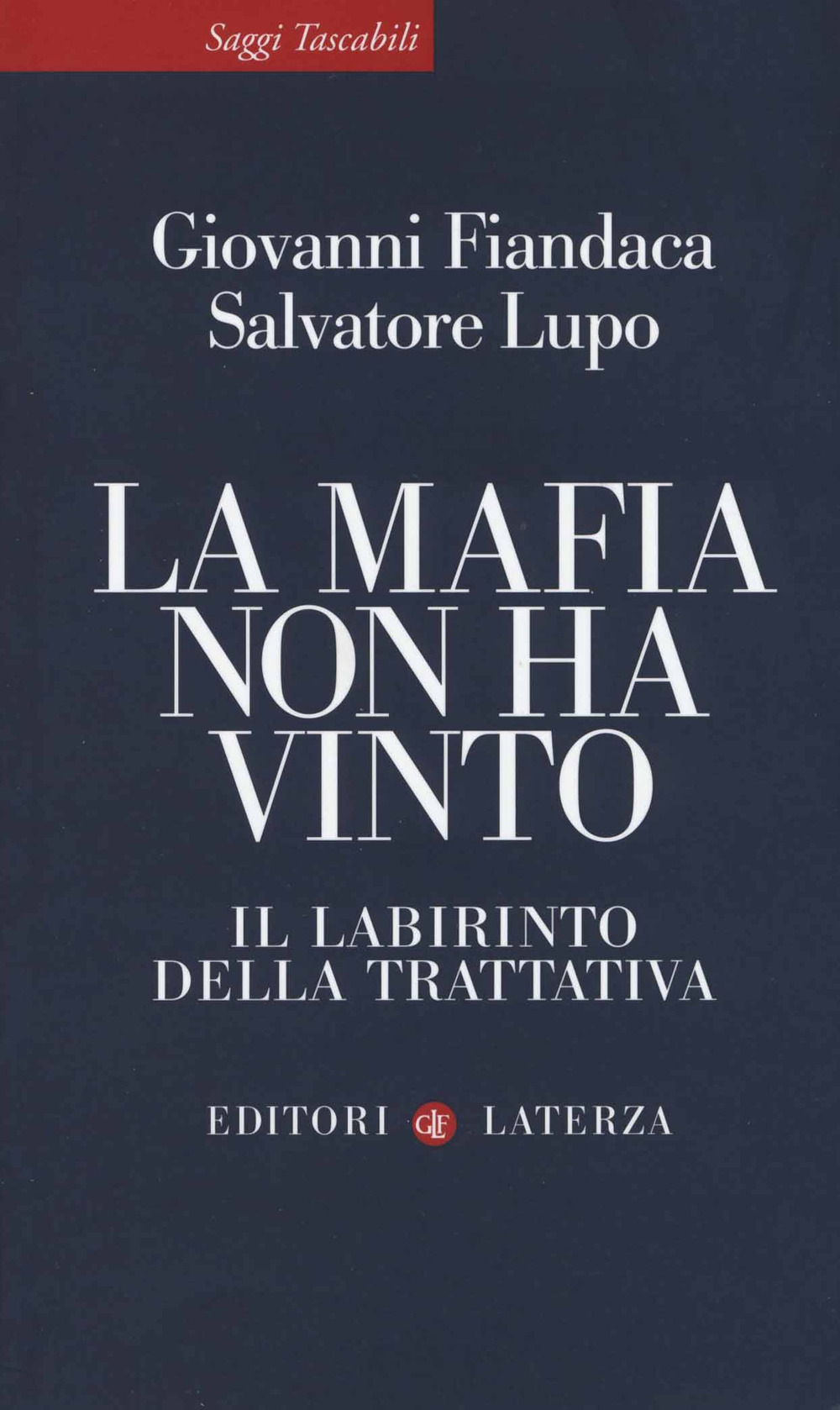
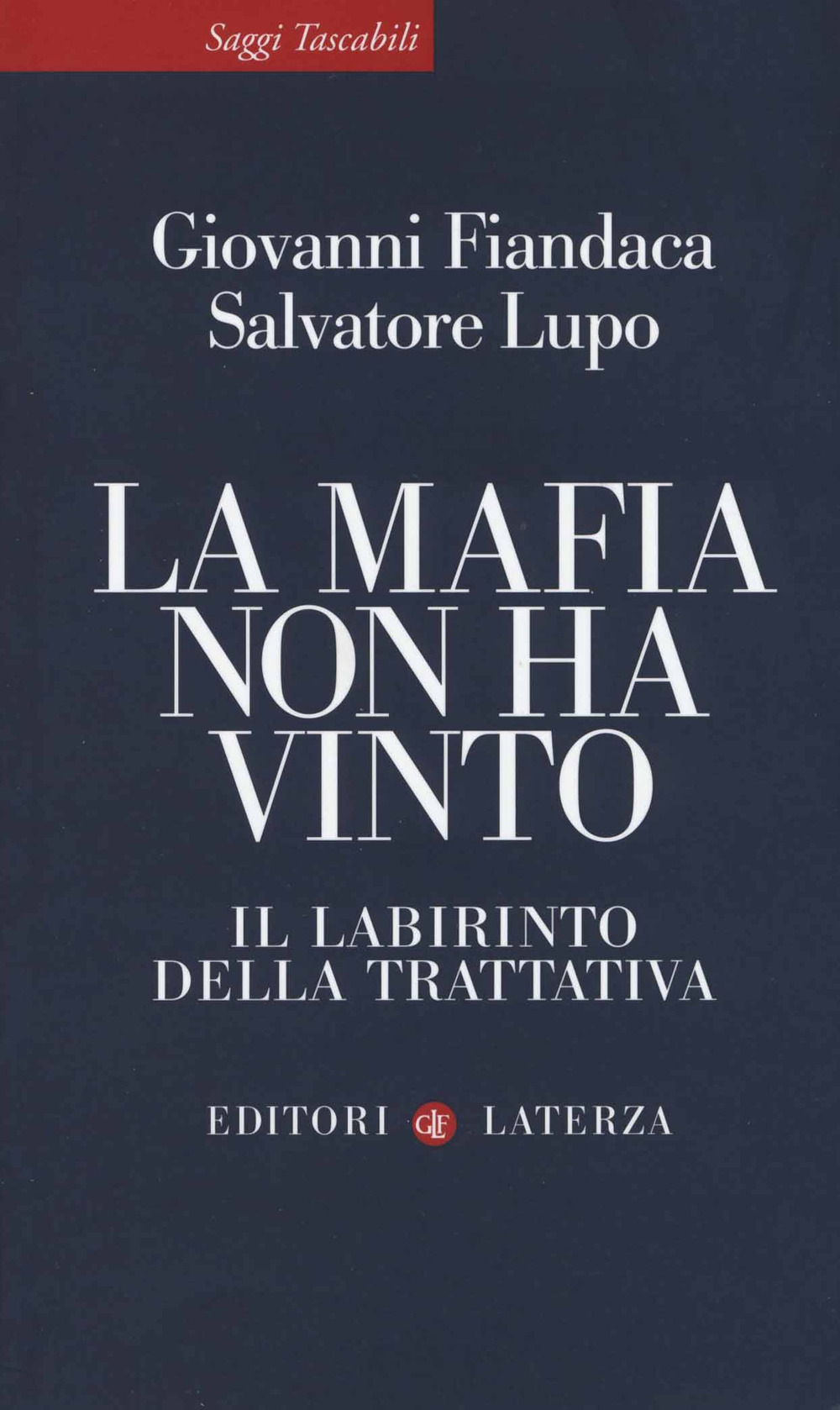
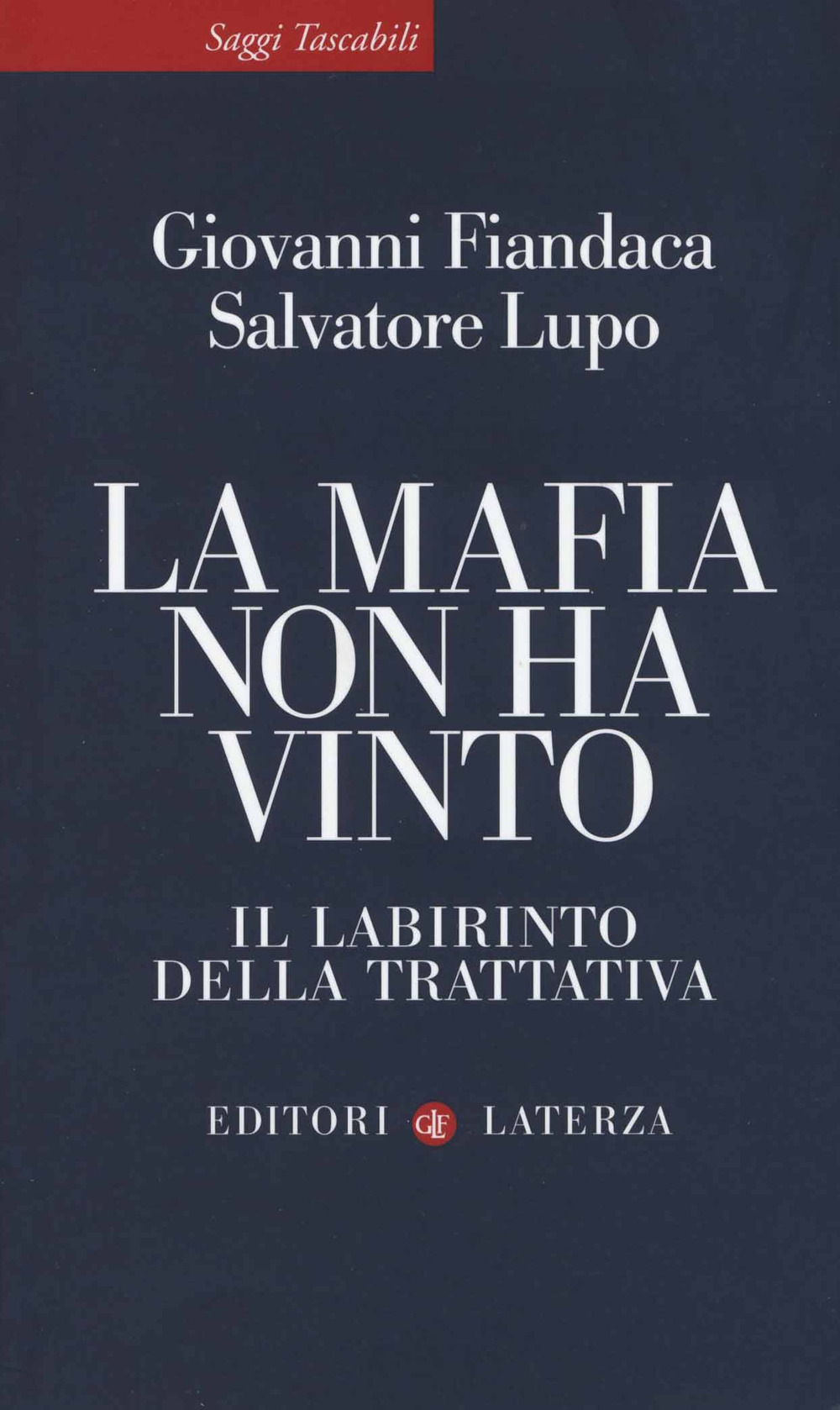
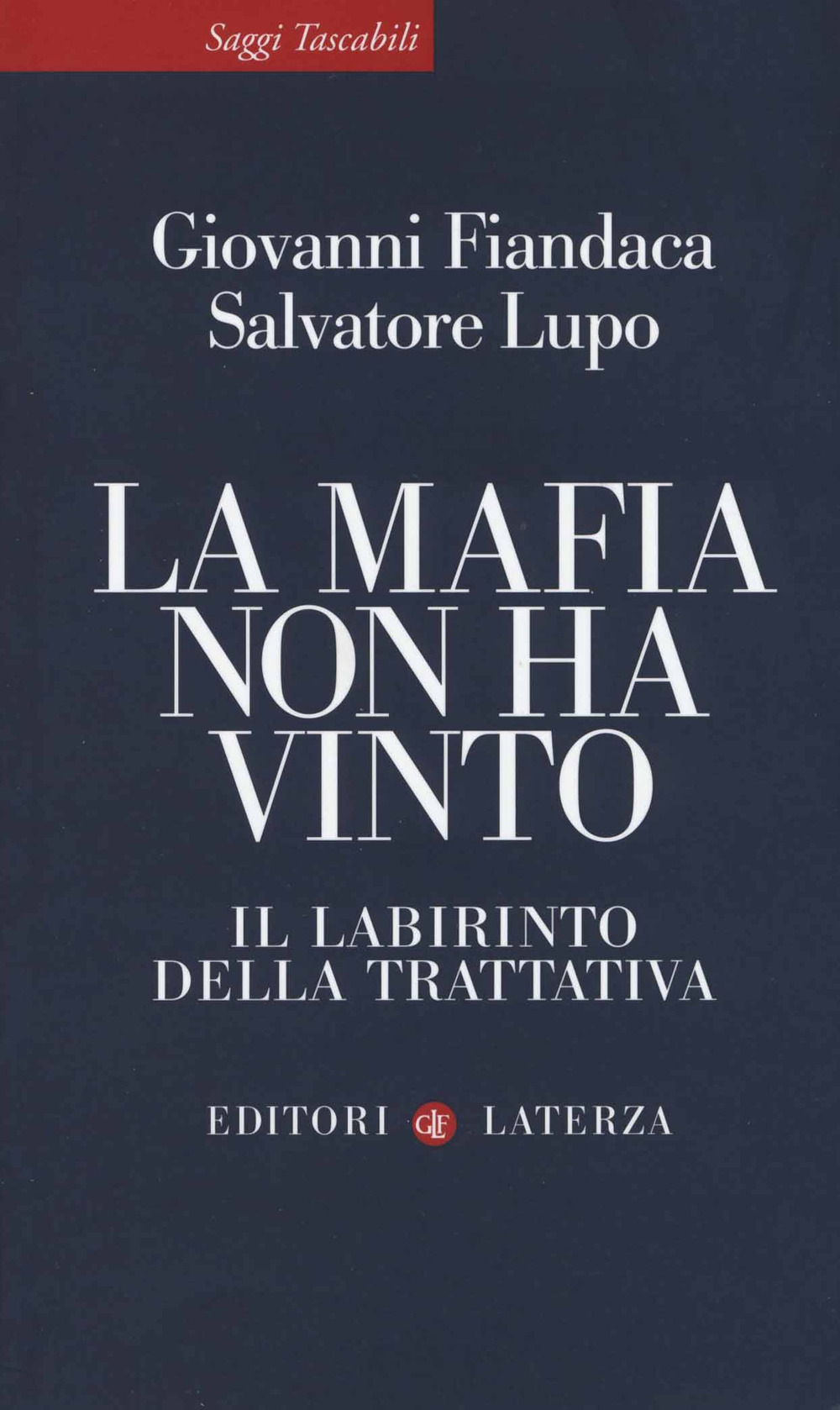
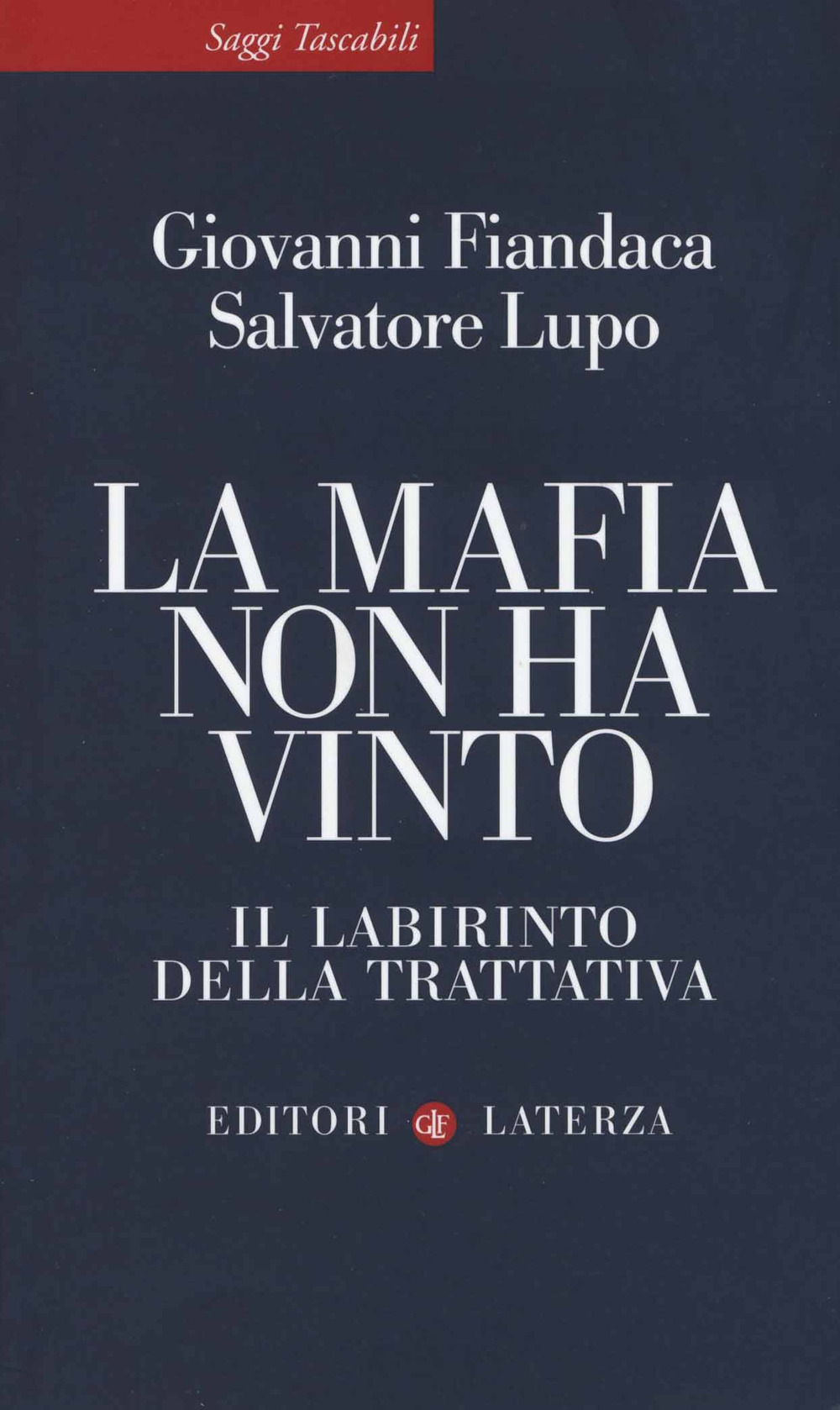
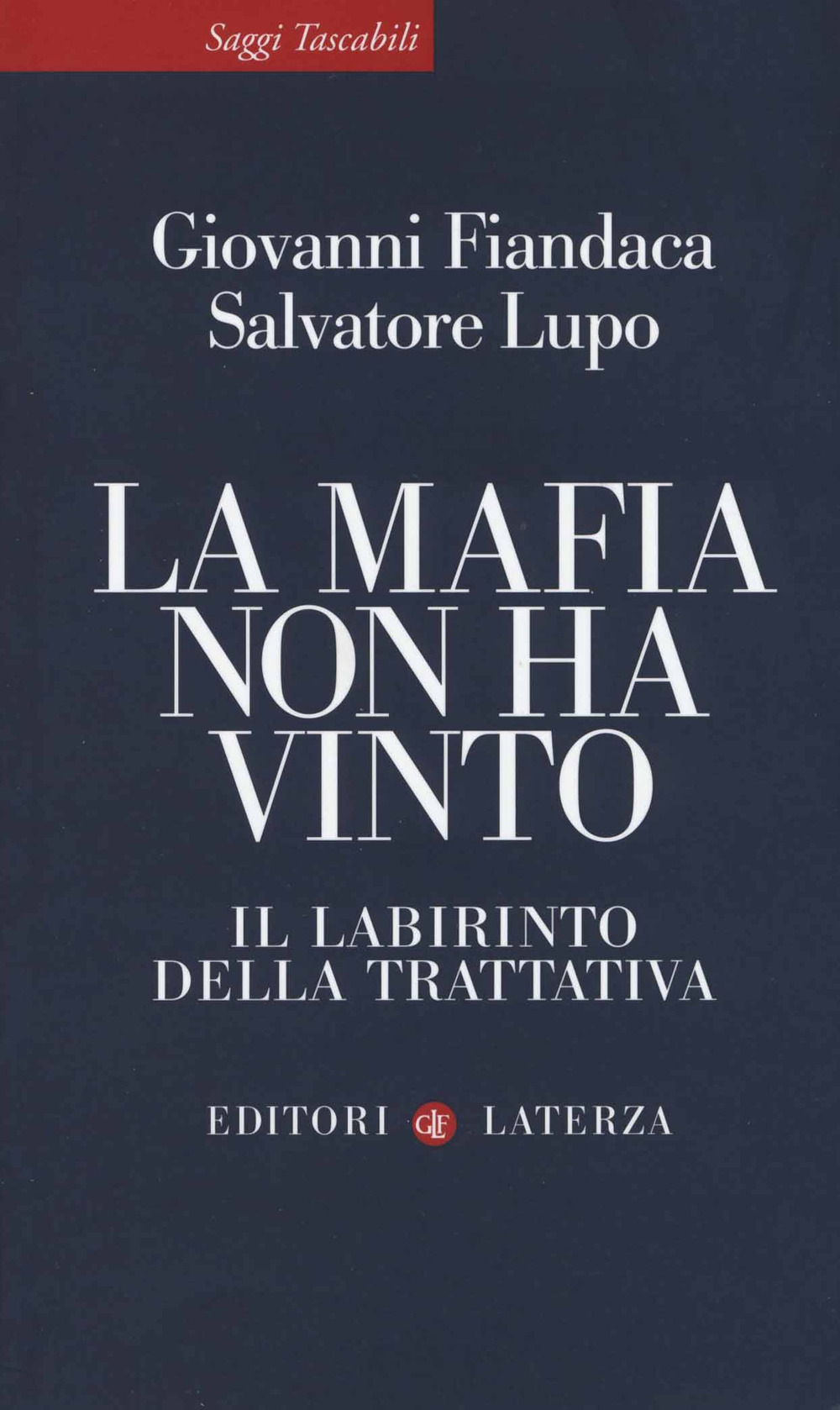
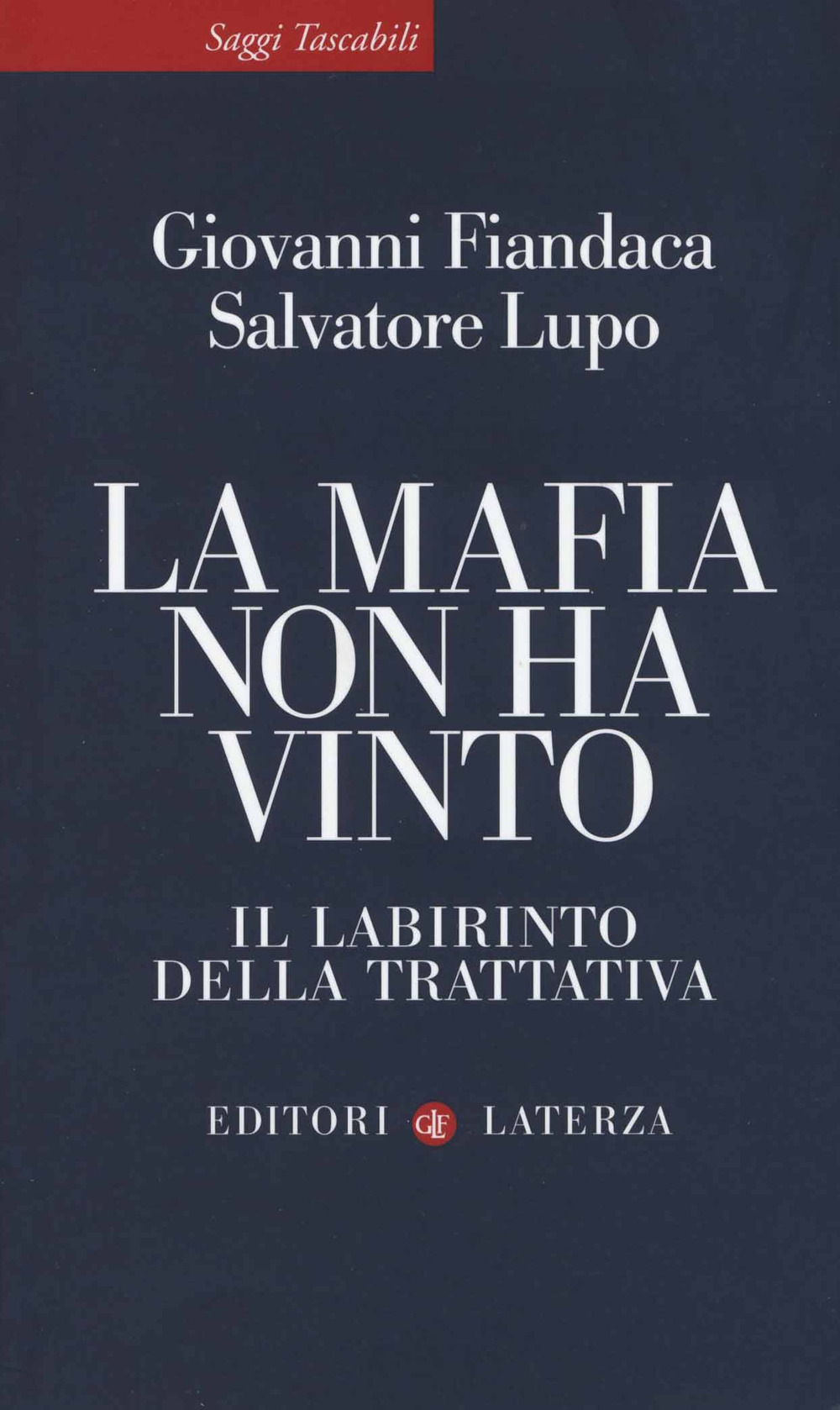
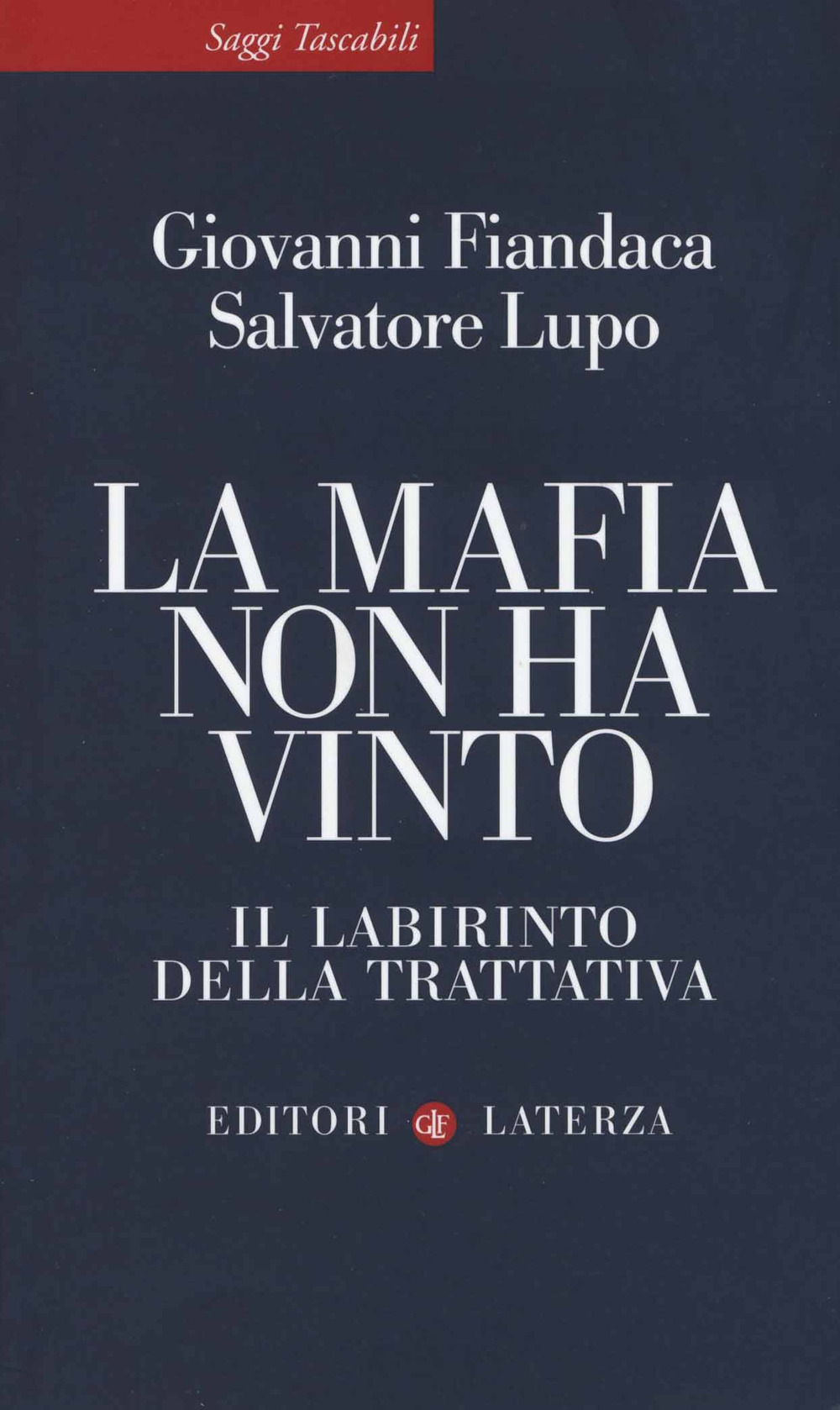
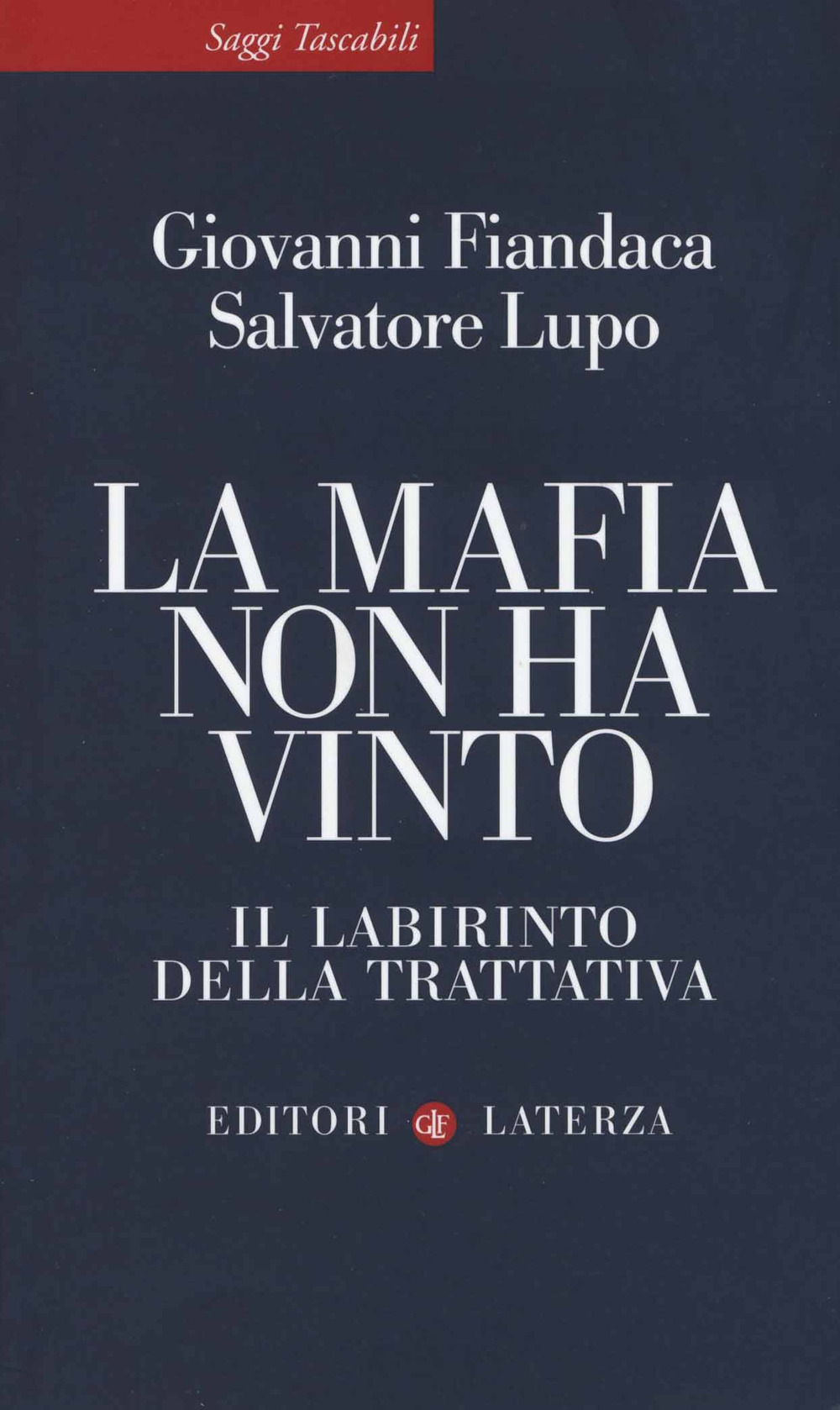
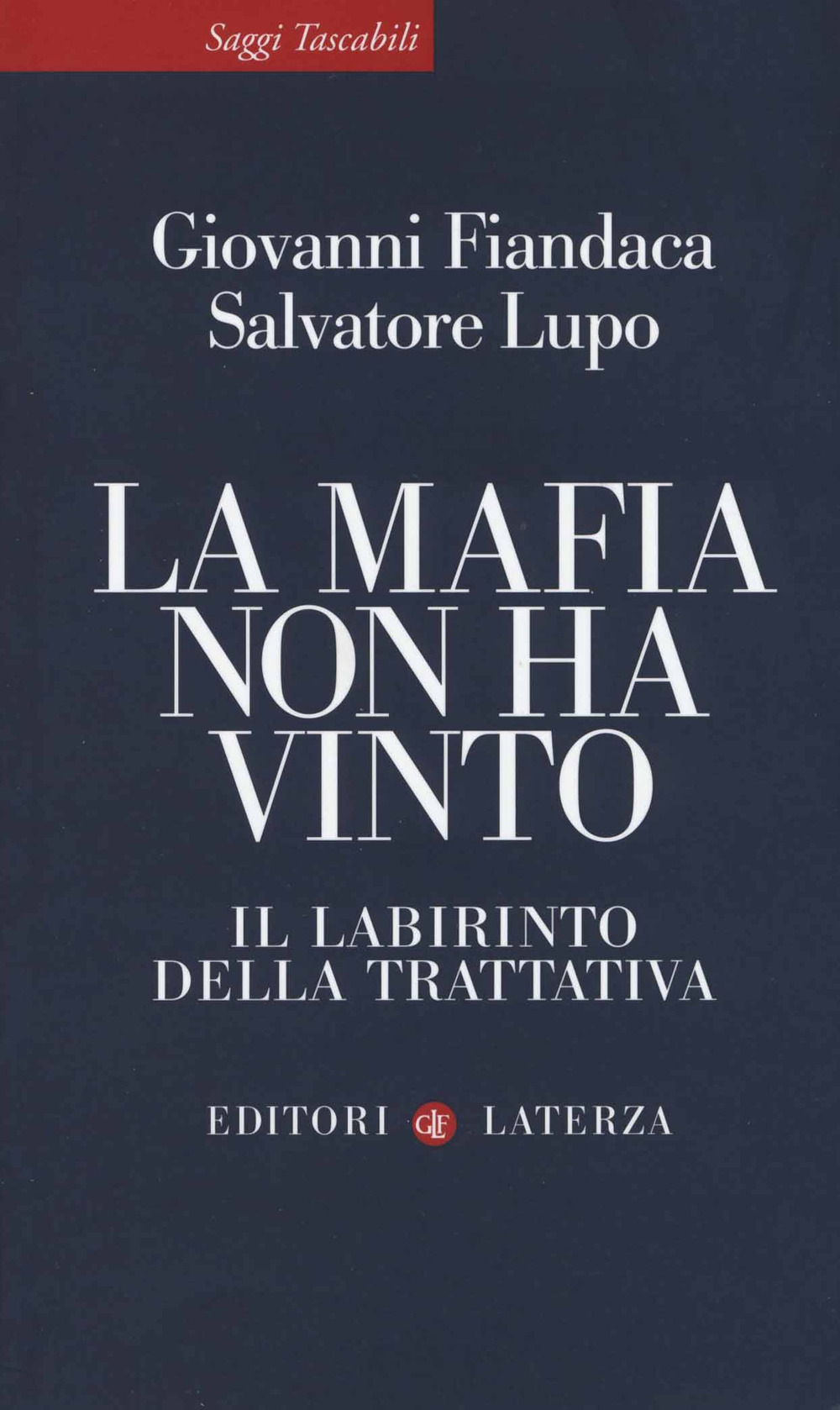
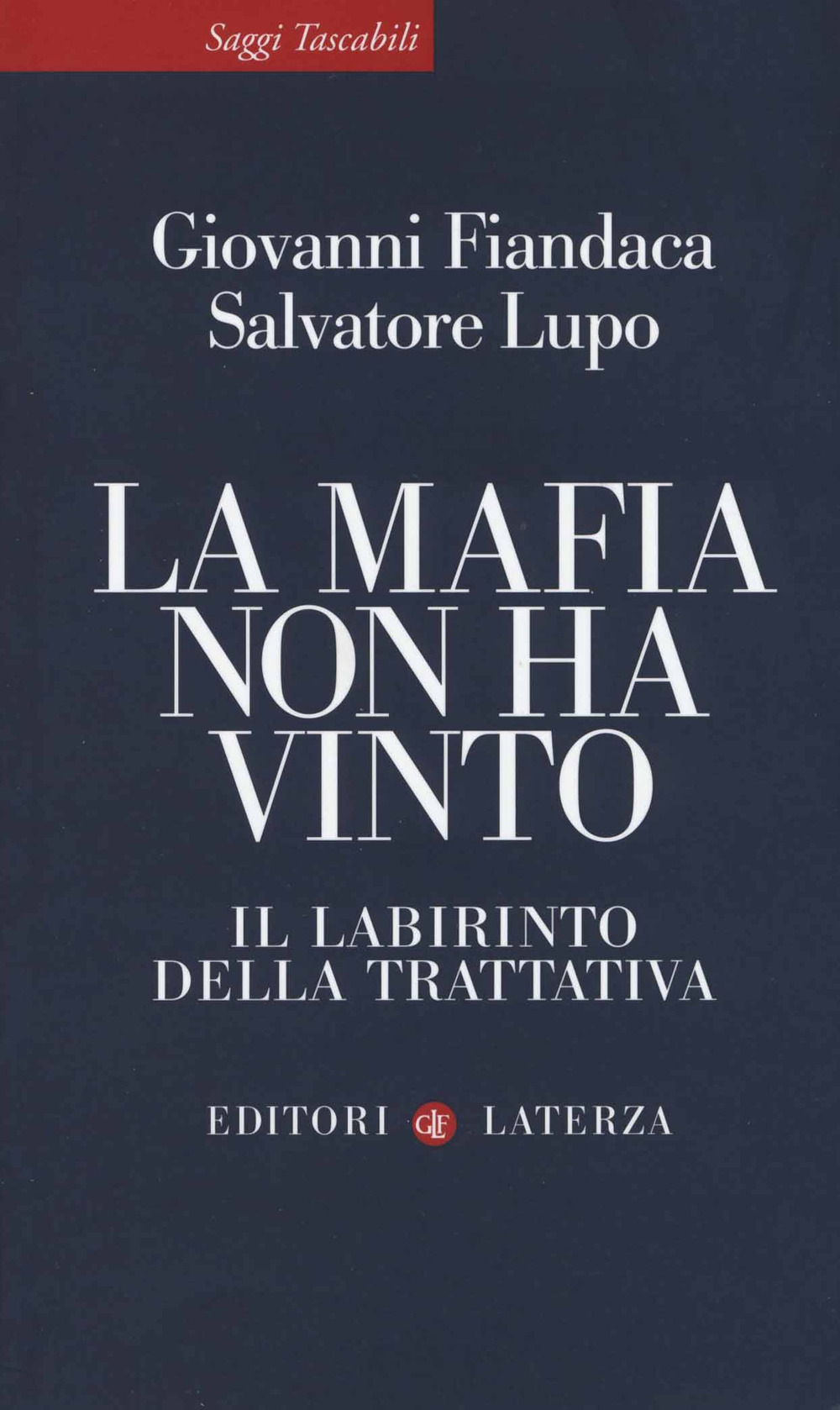
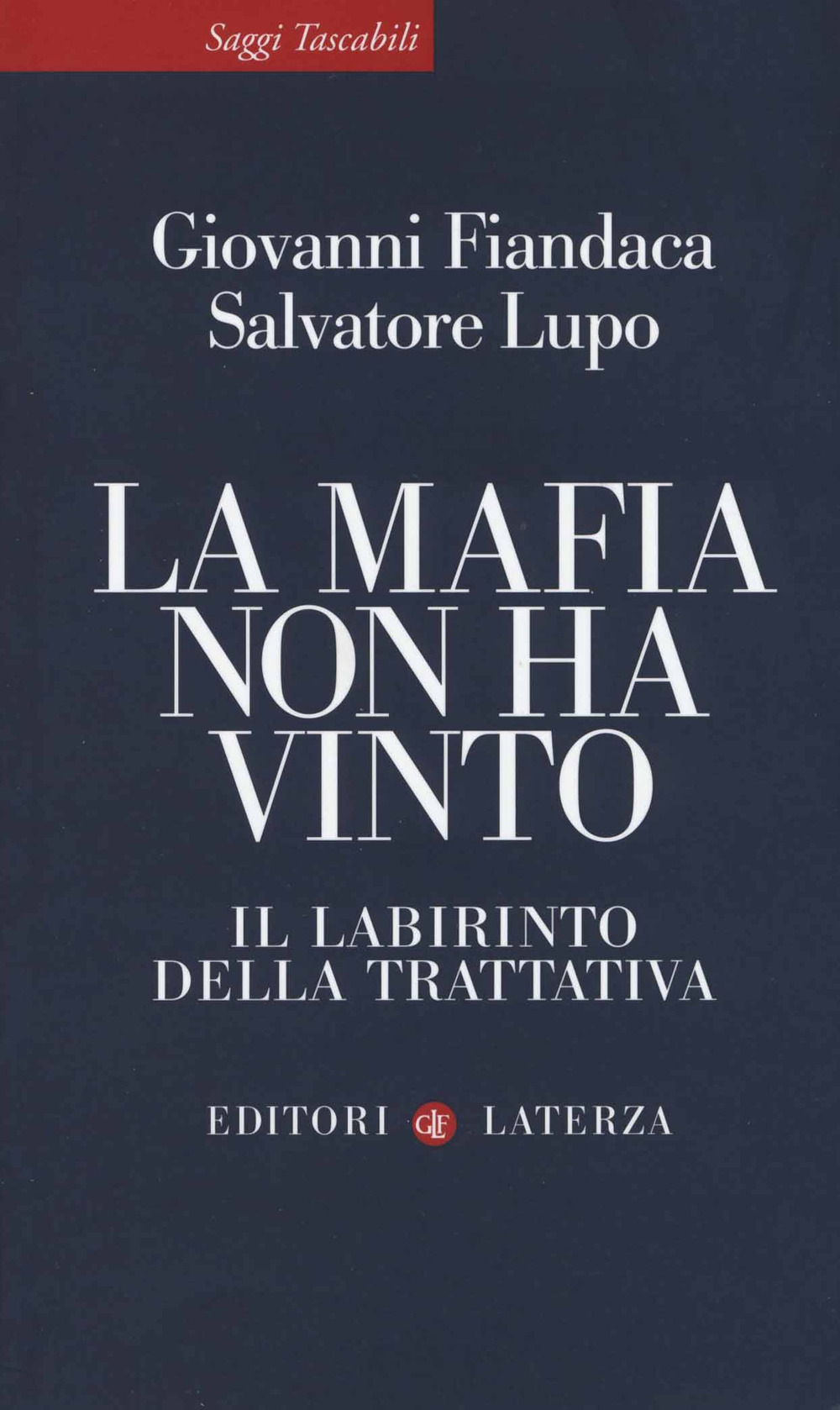
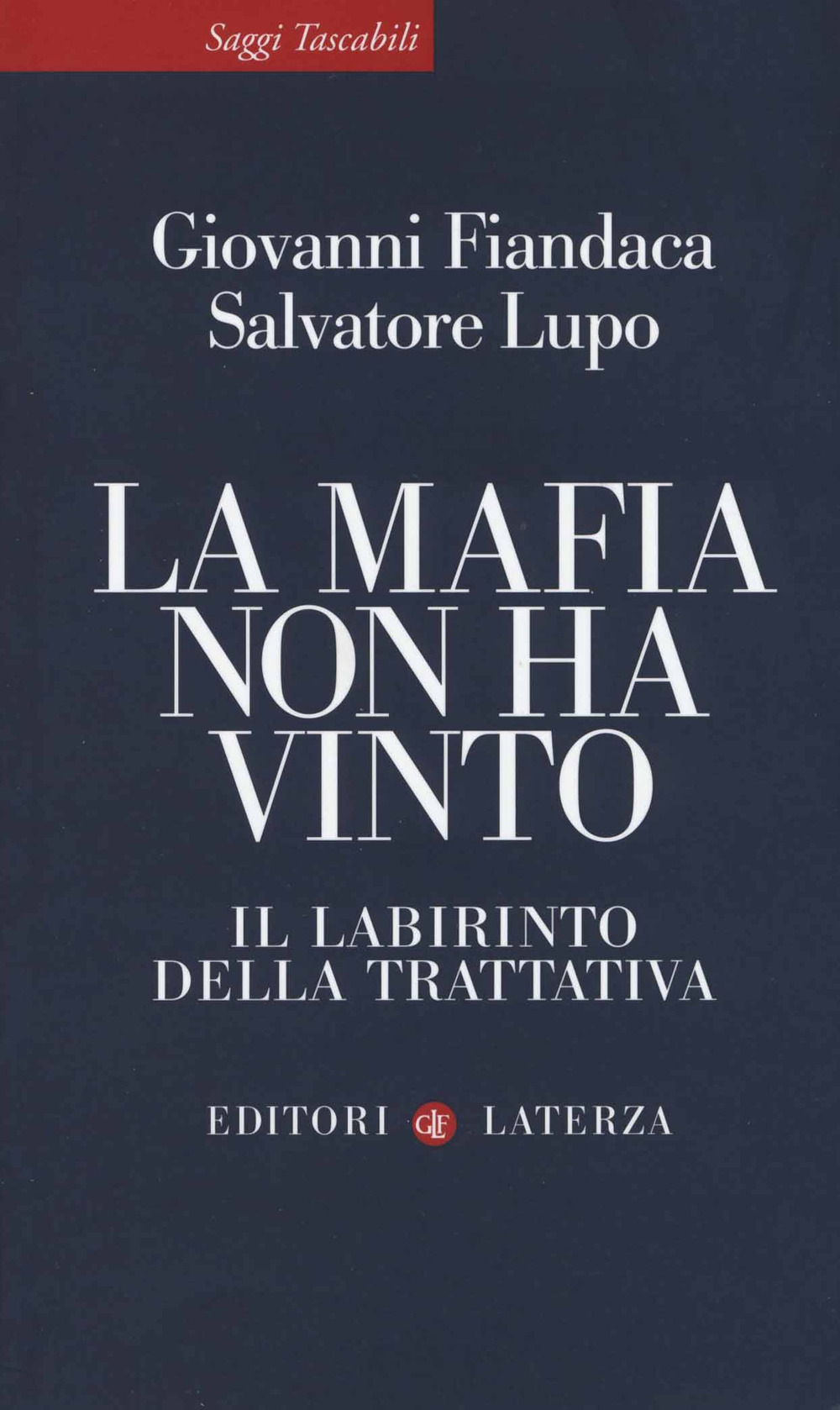
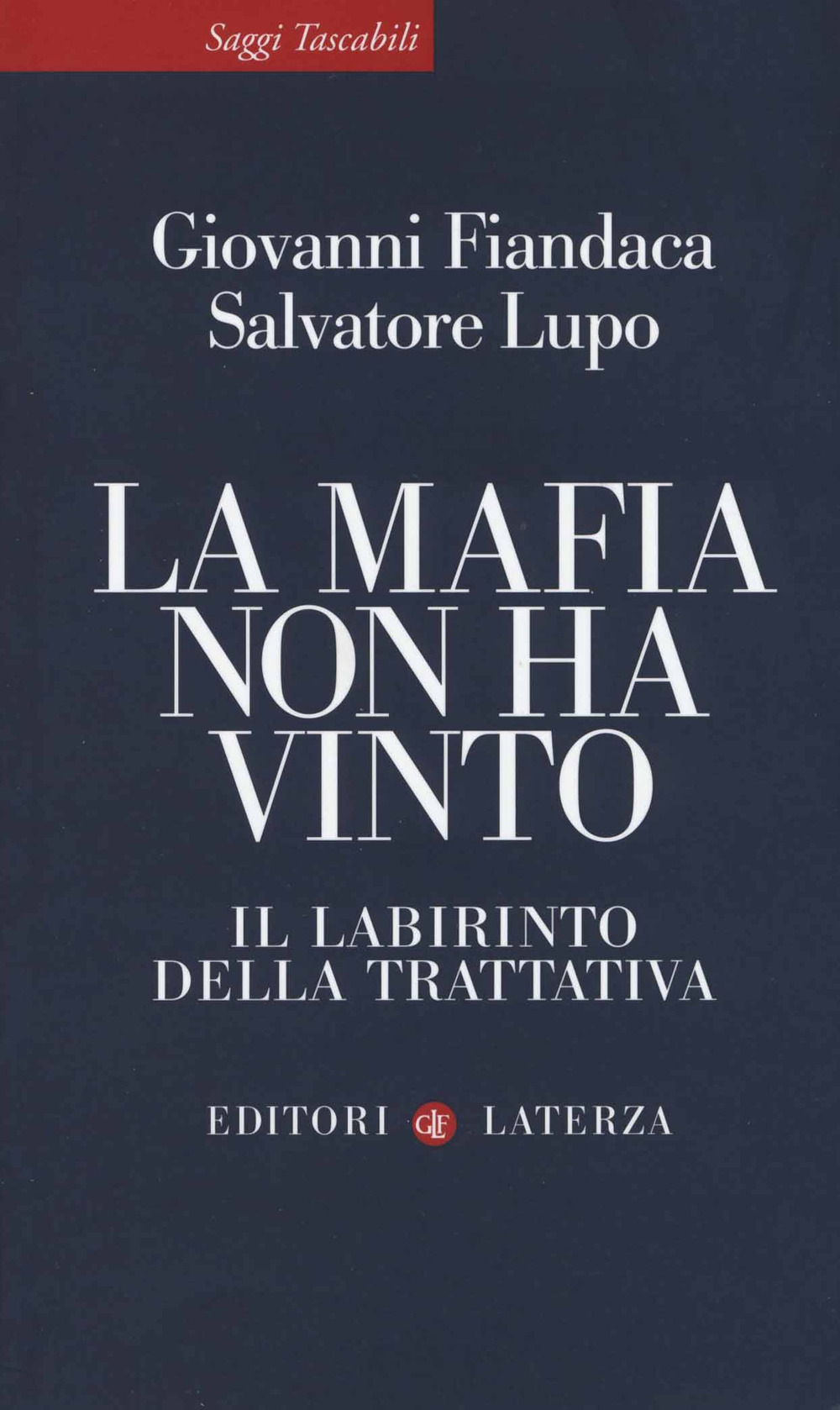
Tutti i formati ed edizioni

Anno edizione: 2014

Anno edizione: 2014
Se la trattativa fosse un reato, se lo Stato avesse ceduto, se la mafia avesse tratto benefici, allora le istituzioni sarebbero colpevoli. Ma non è così. Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo sostengono una tesi sorprendente: l'impianto accusatorio del pool di magistrati di Palermo non regge, i comportamenti di cui all'accusa non sono reato e Cosa Nostra non è stata salvata. Perché dunque si è scelto di celebrare questo processo? Perché gli italiani hanno bisogno di pensare che la mafia abbia vinto (e debba sempre vincere)? Uno sguardo nuovo su un processo ricco di ambiguità, di coni d'ombra, di nodi tecnici da sciogliere, nel quale si fondono e si confondono tre piani: giudiziario, storico-politico, etico.
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
Più che un libro un depistaggio culturale. I due autori contestano l'accusa nei confronti di elementi deviati dello Stato, omettendo molti fatti ormai agli atti e dilungarsi in personali idee della giurisprudenza. Nel saggio di Lupo, in particolare, si trovano molti "Io penso", "a me sembra", "mi pare", di cui il lettore francamente non se ne fa nulla.
Il libro è articolato in 2 parti, lo sguardo dello storico ( S.Lupo ) e quello del giurista ( G.Fiandaca ) più un Appendice finale. L'ho trovato molto molto interessante, un'altra chiave di lettura di questo periodo buio della nostra storia. Lo considero ultra politicamente-scorretto, è normale che sia stato molto criticato, ma pone dei dubbi ( storici e giuridici ) che fanno riflettere. Sottolinea incongruenze, a cominciare dal fatto che il processo di Palermo non sta in piedi nè sul piano giuridico nè storico-politico, dal "reato di trattativa" che non esiste, fino ad arrivare alla lotta fra poteri che si è instaurata nel biennio 92-93, criticando molto la magistratura (vedi Ingroia poi entrato in politica). Ho trovato interessante anche la critica ai mass-media, pare che ormai ci sia la caccia allo scoop a detta degli Autori, criticando la "giustizia delle emozioni" sottolineando che ci si trova di fronte ad una situazione di partigianeria (anche dei paladini antimafia) nel quale ogni assoluzione/archiviazione è data dai "nemici del male" (massoneria servizi segreti politici collusi ecc.) senza appellarsi a valori fondamentali dello Stato di diritto (garantismo penale) e in cui l'informazione appunto gioca ad attrarre più spettatori possibili, giocando all'audience strumentalizzando notizie di fronte a tante inesattezze. Sicuramente comunque la parte che ha fatto più scalpore e il cosiddetto "stato di necessità"("Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona...") in cui i 2 Autori diciamo che giustificano la trattiva per interesse nazionale. Comunque la si pensi è da leggere e riflettere, insieme alla lettura di altri libri che tra l'altro vengono anche citati spesso con accezione negativa ("Io so" di Antonio Ingroia..e io aggiungo altri di Travaglio). Forse la verità non la sapremo mai...chi lo sa, staremo a vedere.
Recensioni
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

L'articolo è stato aggiunto al carrello
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da IBS, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.ibs.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare complianceDSA@feltrinelli.it
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
Siamo spiacenti si è verificato un errore imprevisto, la preghiamo di riprovare.
Verrai avvisato via email sulle novità di Nome Autore