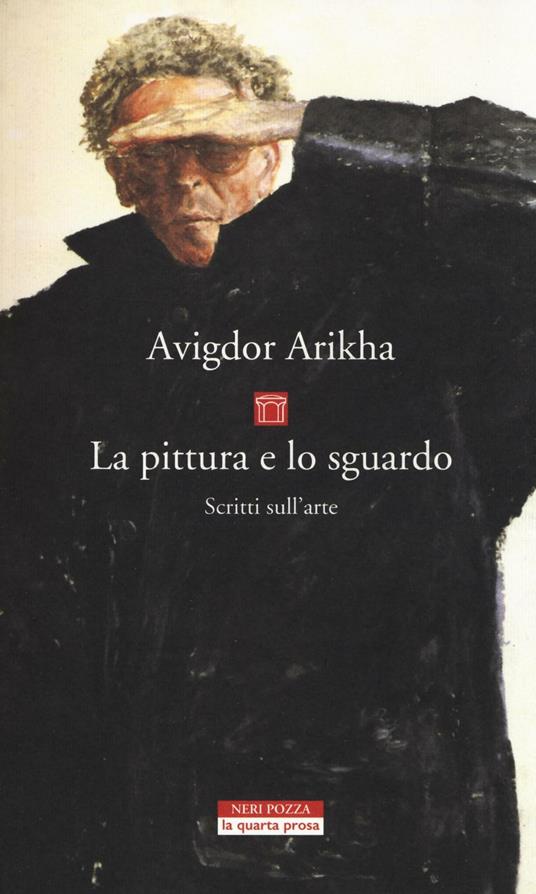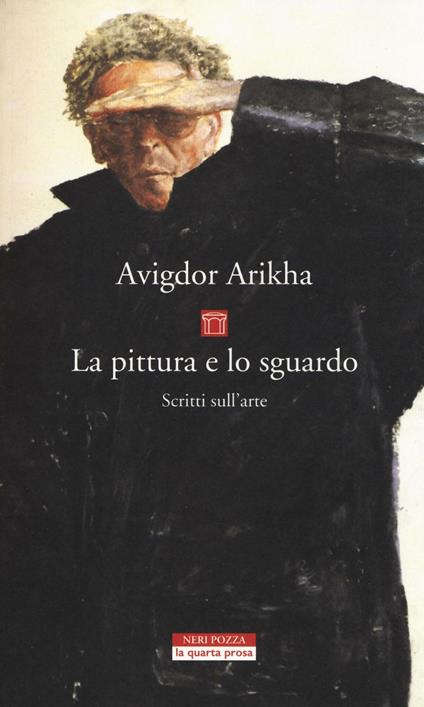L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
La pittura e lo sguardo. Scritti sull'arte
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti











Tutti i formati ed edizioni

Anno edizione: 2016

Anno edizione: 2016
Avigdor Arikha è stato uno dei più grandi pittori della seconda metà del XX secolo. Non tutti sanno che, parallelamente alla sua produzione pittorica, ci ha lasciato un'opera di teorico e storico dell'arte non meno sorprendente per acutezza e originalità, che viene qui raccolta nella sua integralità. Congiungendo lo sguardo del pittore con quello del critico, Arikha riesce a situare l'atto del dipingere in una prospettiva completamente nuova, che lo mostra non semplicemente "da vicino", come qualsiasi storico dell'arte può fare, ma piuttosto "da dentro", nella genesi stessa delle opere. Che si tratti dell'astrattismo cromatico di Velasquez o del nitrito del cavallo graffito nella grotta magdaleniana di Gabillou, dello scacco di Giacometti o del ramo d'oro di Poussin, dell'assolo di Bonnard o del «miracolo logico» di Matisse nell'incontro tra il Jazz e l'Apocalisse di Beatus, della pittura pompeiana di David o del Raffaello di Ingres, noi siamo catturati ogni volta dalla novità del suo sguardo e lo seguiamo mentre penetra là dove quello del critico e dello storico si arrestano: l'individuazione del problema che ciascun pittore ha avvertito e ha cercato di risolvere, talora a dispetto del suo tempo.

Avigdor Arikha, l’arte è un soffio che rimane
Non è certo un caso che tra le prime immagini dipinte che conosciamo, nelle grotte di Pech-Merle, sia rappresentata una mano. Nello stesso istante in cui l’uomo ha sentito quell’impreciso impulso a prendere uno strumento e ha cominciato, per così dire, a dipingere, egli ha voluto mostrare lo stesso soggetto di quel gesto: quella mano non è un oggetto qualsiasi tra quelli che la pittura può rappresentare, ma è la stessa condizione di possibilità di ogni disegno e dipinto. Ogni pittura, infatti, è il prodotto di una mano (o, come si suol dire, di più mani); l’unica cosa, che ogni quadro e dipinto della storia condividono, è questa certezza. Il primo, inconsapevole pittore dell’umanità, insieme ai mammut e ai bisonti che aveva disegnato, ha inteso lasciare l’impronta di quella stessa anonima parte di sé che stava, in quell’esatto momento, inaugurando la potenza di dipingere.
Da quella stessa mano, priva di parole, è partito ogni pittore, e non di rado, negli ultimi secoli, essa ha sentito l’esigenza di descrivere la propria esperienza e il proprio oggetto (d’altronde la scrittura stessa non discende, in fondo, da quella mano?). Gli scritti di Avigdor Arikha (1929-2010), uno tra i grandi pittori del nostro tempo, editi ora da Neri Pozza a cura di Monica Ferrando, che ne firma anche l’ampia introduzione, rappresentano tra i più penetranti e originali resoconti che possediamo sull’oggetto proprio della pittura. Bisogna subito avvertire che questi scritti di Arikha non andranno situati insieme alla copiosa, spesso omogenea letteratura che anche alcuni sommi pittori ci hanno lasciato, ricca di riflessioni e di richiami evocativi al proprio mondo pittorico o, a volte, affaticata da apparati concettuali che tentano di giustificare e legittimare una determinata prassi artistica. Già aprendo una pagina di Arikha ci rendiamo conto immediatamente che qui si respira una diversa aria: che si analizzi l’interdetto veterotestamentario delle immagini, in rapporto all’opera di pittori ebrei, o la “forma autoritratto” in Rembrandt; che l’Autore contempli il braccio ripiegato di un nudo femminile di Degas o che svolga una breve, straordinaria archeologia della nozione di “capolavoro” in Occidente, è sempre in gioco una certa idea della pittura. Nulla è più lontano da Arikha del gesto, molto diffuso nel suo tempo, dell’artista che vuole costruirsi una concettualità nuova e su misura, che spieghi adeguatamente la propria opera e ne persuada alla fruizione. Piuttosto, come nella tradizione ebraica, le idee dell’autore non vengono mai presupposte o dichiarate in quanto tali, ma assumono la forma espositiva del commento (o anche, come qui, del saggio storico e critico), che non può fare a meno di esercitarsi su alcune determinate opere.
Che si eserciti in testi di storia dell’arte o d’occasione, che tratti della pittura moderna o che affronti temi più squisitamente teorici, quella di Arikha resta una scrittura chiara, precisa, documentata, che non cede mai al compiacimento o alla rêverie, in cui le fulminee intuizioni dell’artista sulla propria arte sono sostenute dalla dottrina dello storico, e in cui egli rivela di essere, come pochi tra i grandi pittori della sua generazione, profondo e inatteso connaisseur e critico d’arte, estremamente consapevole delle inquietudini del proprio tempo, devoto, nelle sue analisi, del vivo dettaglio in cui si dice risieda il buon Dio.
Questa esigenza o attesa del passato, che pervade il metodo critico di Arikha, rappresenta il contrario di uno sguardo malinconico e nostalgico rispetto a una tradizione ritenuta inaccessibile: in quanto il passato ci attende nella stessa misura in cui noi impazientemente lo attendiamo. Rispondendo a questa attesa, egli ci dà in questi saggi uno straordinario e insostituibile sguardo, moderno perché inattuale, sul presente.
Il legame tra filosofia e pittura è stato enunciato per la prima volta, forse nella maniera più chiara, da Giordano Bruno. Non si trattava ovviamente, per lui, di invitare i filosofi a dare prova di pittura, o i pittori a mostrare la propria competenza filosofica, quanto piuttosto di rintracciare in queste due arti una somiglianza fondamentale. Quale?
Il valore riconosciuto da Arikha alla pittura ha a che fare molto da vicino con la stessa natura delle cose. Lo scritto sull’insegnamento delle arti, nato come una conferenza all’università della Pennsylvania a una classe di giovani artisti, si apre, con apparente paradosso, affermando che «L’arte, per principio, non si impara. È nell’essere». In un saggio successivo Arikha afferma: «In pittura non ci sono ricette. Si tratta di un’eco dell’essere. Dipingere è un atto che si può paragonare alla pietrificazione o al gelo, ma anche all’ontogenesi; essa trasforma delle sensazioni visive comunicandole all’essere singolo». Questa potenza ontogenetica, e questa appartenenza originaria della pittura all’essere, è ciò che costituisce l’indubbio interesse filosofico del pensiero di Arikha (e anche del pensiero dipinto nei suoi quadri). Con queste dichiarazioni, infatti, che rivendicano il carattere assolutamente specifico dell’arte pittorica, Arikha intende strappare la pittura al dominio dell’estetica per restituirla, così, all’ontologia. Più la pittura resta vicina alla propria vocazione, più essa rivela il proprio legame con la filosofia. Essa infatti, nella sua più originaria intenzione, dimostra di essere in un rapporto particolare con ciò che i filosofi greci hanno chiamato physis, il nascimento delle cose. Nascimento, però, non è movimento: ma arresto e pietrificazione. La pittura e la filosofia sono quelle arti, potremmo dire, che congelano il flusso inarrestabile delle sensazioni e delle rappresentazioni per giungere infine a esibire l’istante di nascimento di ogni cosa.
Nel gesto del pittore, mano e occhio si congiungono fino a invertire le loro proprie funzioni: la mano («strumento di perdizione o di rivelazione») osserva e contempla, è capace di vedere con maggiore trasparenza dell’occhio; l’occhio, invece, traccia linee e contorni, disegna e quasi tinge il proprio oggetto con maggiore destrezza della mano. Potenza ricettiva e potenza attiva, materia e mente, sono qui in un rapporto di perfetta congiunzione e tendono a confondersi. Il rapporto tra mente e materia, oggetto della filosofia, è lo stesso che la pittura genera attraverso l’occhio e la mano: la mano contempla e l’occhio crea le forme, le due attività sono ora inseparabili. Entrambi agiscono e patiscono l’azione dell’altro. Questa identità dinamica, e mai inerte, tra l’occhio e la mano, che percorre e permane in un’opera d’arte come la sua verità, Arikha la chiama – nel saggio bellissimo che apre la raccolta – il «soffio»: «L’arte non è nulla. È un soffio. Con il soffio passa e nel soffio rimane».
Recensione di Emanuele Dattilo
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri