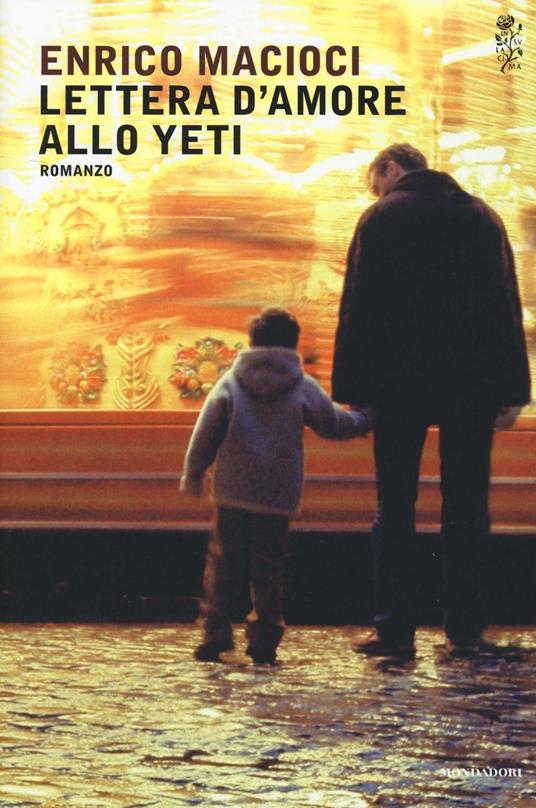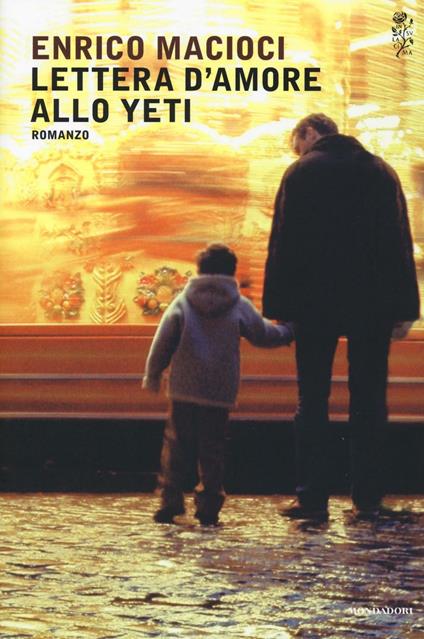L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Lettera d'amore allo yeti
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti













Tutti i formati ed edizioni

Anno edizione: 2017
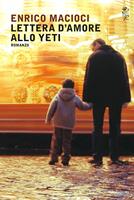
Anno edizione: 2017
Promo attive (0)
Macioci riesce, con straordinaria efficacia, a tratteggiare i passaggi più oscuri dell'animo umano e al tempo stesso a raccontare con delicatezza il rapporto tenero ed esclusivo tra un padre e un figlio.
«"No, Nic. Non l'ha presa lo yeti."
"Peccato" commentò. Non mi toccava più la schiena con le mani e per un secondo temetti che fosse scomparso.
Invece soggiunse: "Peccato che non l'ha presa lo yeti, papà. Almeno potevo chiedergliela indietro."»
Come si fa a sopravvivere quando la tua giovane moglie ti è morta accanto, una notte, andandosene in un istante e lasciandoti solo con un figlio di nemmeno sei anni? Riccardo non lo sa come si fa, ma in qualche modo ci sta riuscendo. Sono passati otto mesi da quando Lisa non c'è più, e padre e figlio si sono trasferiti per l'estate in una casa al mare, acquistata poco tempo prima della scomparsa di Lisa. Nicola è un bambino sveglio e sensibile, e ha una grande passione per lo yeti: è il suo argomento di discussione preferito, ne è affascinato e un po' lo teme. Riccardo è tormentato da un sogno ricorrente, le sue notti sono agitate e gettano ombre sulla quiete del comprensorio in cui abitano. Che significano le ambigue considerazioni della signora Lepidi, un'anziana untuosa che pare al corrente di pericolose verità sull'identità di un comune vicino di casa, Teodoro Inverno, un uomo massiccio e solitario con cui Nicola si ferma per ore a chiacchierare, inspiegabilmente calamitato? Le giornate scorrono, nei ritmi quotidiani della villeggiatura. Nicola ogni pomeriggio partecipa alle attività organizzate da una giovane animatrice dell'hotel vicino. Riccardo lo sorveglia dai tavolini del Long John Silver, un bar sulla spiaggia gestito da Walter, col quale ha in comune una passione per Stevenson e per i discorsi filosofici. Intanto conosce Ismaela, una cameriera affascinante, che sembra nascondere un segreto. La speranza di una ritrovata normalità carezza la mente di Riccardo, ma la tenebra torna ad assediare la sua vita e quella di suo figlio. L'animatrice cui Nicola si era affezionato scompare all'improvviso. Ogni ricerca si rivela inutile e Riccardo scopre che in quello stesso punto sono già sparite quattro persone negli ultimi anni... Chi è l'individuo che appare in certi scatti fotografici e le cui mani hanno qualcosa di mostruoso? E perché ogni volta che passa accanto a un chiosco abbandonato a forma di limone Riccardo viene assalito da un brivido? Con un libro sorprendente per originalità e qualità della scrittura, Macioci si conferma uno degli autori più interessanti della sua generazione. Lettera d'amore allo yeti è un romanzo che sfugge alle classificazioni, un testo senza tempo, sospeso tra E.T.A. Hoffmann e Stephen King, spaventoso e lirico, capace di inquietare e sedurre con le sue atmosfere.
Indice
«Papà?» Nicola mi toccò la schiena. «Secondo te lo yeti scende in spiaggia?» Sapevo che stava fissando la fila di cabine verniciate di bianco e, poco oltre, gli ombrelloni che si stagliavano sul mare. Il pomeriggio era tardo e dolce.
«Uhm» dissi io rallentando l’andatura, e tacqui per alimentare la sua curiosità. Yeti, sasquatch, bigfoot e grassmann avevano preso il posto dei dinosauri nella sua immaginazione, con una lieve ma inequivocabile preferenza per lo yeti. Trascorrevamo ore davanti al televisore o su YouTube a caccia dello yeti, seguendo documentari più o meno credibili – da History Channel a “Voyager” – e Nicola vi si dedicava con lo zelo feroce dei bambini, dimenticando l’appetito e bagnandosi i palmi di sudore.
«Papà?» Mi solleticò i fianchi con le mani e la bicicletta sbandò. Una signora anziana, che pedalava a fatica trasportando sul manubrio una voluminosa busta del Carrefour, ci lanciò un’occhiataccia. Accelerai. Mi sentivo bene.
«Papà!!! Secondo te lo yeti scende in spiaggia???» ripeté Nicola tempestandomi la schiena di pugni. Era diventato forte. Stava per compiere sei anni e ciò mi procurava angoscia e sollievo. Eravamo come personaggi d’un videogame sul punto di terminare un livello per passare a quello successivo.
«Un attimo, un attimo» mi difesi tenendo dritta la bici. A quell’ora il lungomare era pieno di ciclisti, pattinatori e mamme con le carrozzine. «Fammi pensare.» Ci sfrecciò incontro una bionda sui rollerblade, leggings neri e cuffiette alle orecchie, allungando il passo con fluidità.
«Hai pensato?»
«Credo di sì» m’affrettai a rispondere. «Sì, direi che lo yeti scende fino in spiaggia.» Tacemmo entrambi. Le bancarelle spargevano aroma di zucchero filato, una musica allegra e dozzinale tappezzava l’aria e i gabbiani tracciavano le loro eleganti traiettorie quasi a pelo dei tetti. «Non adesso però» puntualizzai rompendo l’incantesimo – chiacchierare coi bambini è questione d’equilibrio, non si può concedere troppo alla realtà ma neppure troppo poco. La mia voce suonava seria, una voce per faccende importanti e forse pericolose.
Nicola rifletté. Non ci saremmo spesi in simili discorsi – assurdi e profondamente intimi – ancora per molto. A settembre avrebbe iniziato la prima elementare. Addio infanzia. Si passava al livello successivo. E di che si trattava? Perché un padre non possiede da qualche parte un libretto d’istruzioni? Una mappa per non sbagliare ai bivi più importanti?
Al termine d’una congrua pausa Nicola domandò: «E quando scende in spiaggia lo yeti, papà, se non scende adesso?».
«Quando?» Smisi di rimpiangere la mappa e mi concentrai.
«Sì.»
«Dopo il tramonto» spiegai senza esitare. Nicola era sveglio e soppesava ogni parola. «Quando la gente rientra in casa per cena e la spiaggia resta vuota e gli ombrelloni vengono chiusi e anche le sale giochi e i bar e gli stabilimenti vengono chiusi, ed è tutto buio, e si sente solo il rumore del mare, e la luce della luna dipinge quelle scie…»
«D’argento» m’interruppe lui puntuale. «Le sue scie d’argento.»
«Esatto» confermai, reprimendo un moto d’orgoglio. Ero solo un professore d’italiano e storia delle superiori ma cercavo di trasmettere a Nicola il poco in mio possesso: una discreta fantasia e una buona proprietà di linguaggio. Quando mia moglie e io ci accorgemmo che Nicola stava imparando a leggere e scrivere con largo anticipo smettemmo di stimolarlo. I bambini prodigio non c’interessavano, su questo non nutrivamo dubbi, benché sia complicato per un genitore mettere a fuoco cosa si aspetta da un figlio. Genitori e figli diventano soggetti ben distinti solo quando il danno dell’amore è compiuto, e l’amore è più subdolo dell’odio: amiamo i nostri figli, perciò li danneggiamo. Mi fermo qui; esattamente come voi, non ho ricevuto un manuale d’istruzioni. Stimoli o meno, Nicola si rivelò in gamba. Un bambino di media statura, magro, coi capelli castani lisci abbastanza lunghi e grandi occhi grigi nei quali brillava un tepore malinconico, un avanzo di tramonto dopo un giorno caldo ma nuvolo.
«Le scie d’argento, papà» ripeté, dato che non parlavo più.
«Le scie d’argento» lo assecondai. «Quando la luna disegna le sue scie d’argento e le creste delle onde sono candide e le tenebre si allungano eccetera eccetera… be’, può darsi che allora lo yeti scenda dalle montagne per tuffarsi in mare.»
«Davvero?» Le sue unghie nella mia t-shirt, la sua voce acuta e vibrante.
«Davvero. E se a notte fonda andassimo in spiaggia troveremmo grosse impronte, tipo quelle che fanno vedere in tv.»
«Ma andare in spiaggia a notte fonda è pauroso… E se poi s’incontra lo yeti?» obiettò lui, bollendo sul seggiolino montato sopra il portapacchi.
«È vero» ammisi.
«Tu avresti paura, papà?»
«Un po’» concessi. Sapevo che la mia paura, fino a un certo segno, rinfocolava il suo coraggio.
«Però potremmo trovare le impronte domani mattina» insisté. Non stava fermo un attimo.«Chissà.» Mi piaceva, e nonostante tutto mi piace ancora, alimentare il mistero – un paradosso che non smette di turbarmi. «Il vento e la marea cancelleranno le impronte prima che arriviamo in spiaggia.»
«E se andassimo in spiaggia presto presto?»
«Le cancelleranno prima dell’alba, Nic.»
Lui aggirò il momentaneo sconforto. «E che altro fa di notte lo yeti sulla spiaggia, oltre a tuffarsi?»
S’ostinava talvolta a venire in bici con me, e non avevo cuore di negarglielo quantunque il seggiolino lo contenesse appena. Il vento fresco m’asciugava il sudore sulla t-shirt appiccicata alla pelle. Il sole obliquo sfiorava la strada, le palme e gli edifici con la tristezza struggente che precede il buio. Un caos di tandem, risciò, persone sugli skateboard, ragazze in pantaloncini corti e ragazzi in maglietta aderente senza maniche riempiva il lungomare. La pineta più oltre appariva d’un verde scuro, simile a un mucchio di cenere; gettava un’ombra netta, cinta dalla spiaggia. Di là dalla pineta s’intravedeva il ponte di legno che scavalcava la foce del fiume. Presso la foce i pescatori tendevano le lunghe canne luccicanti. All’intorno le fitte paludi ospitavano tortore, cuculi e un’incredibile quantità di rane, che solo verso il tramonto diradavano il loro concerto sprofondando il fiume in una pallida quiete. Dopo il ponte Colombaia si arrendeva alla campagna, terreni incolti scivolavano nelle acque turchesi, la civiltà smarriva in pochi metri.
«Uno yeti può fare un sacco di cose oltre a tuffarsi» replicai, saggiando un benessere inconsueto; mi sentivo… connesso. In connessione con la nervosa energia di mio figlio. «Può sedersi sul bagnasciuga e riposare, per esempio. Tira fuori la lunga lingua – una lingua lunga come una cravatta – e ansima. Sgranocchia un pezzo di legno trasportato dalla risacca. Raccoglie conchiglie o granchi morti oppure cocci di vetro – grossi però, che tagliano se li calpesti. Ma le sue mani sono troppo dure per tagliarsi. A volte mangia sia i granchi morti che le conchiglie, li sbriciola coi suoi denti robustissimi. E se si arrabbia…»
«Se si arrabbia che succede, papà?» Nicola afferrò due lembi della mia pelle assieme alla t-shirt.
«Be’» considerai, «potrebbe sradicare un ombrellone oppure sfasciare un pedalò, o addirittura rovesciare i tavoli e le sedie o il gazebo di un bar. Potrebbe rompere un distributore delle bibite, sollevarlo e scagliarlo lontano o sfondarlo con un pugno… A volte trovano questi distributori con un grosso buco nel mezzo… Ma dovrebbe essere arrabbiato sul serio.»
«E che cosa lo fa arrabbiare sul serio?» domandò lui – non si trattava della prima e nemmeno della seconda o della quinta volta che parlavamo della faccenda. Per la verità ne discutevamo ogni sera dacché, una settimana prima, c’eravamo sistemati a Colombaia.
«La confusione» rivelai. «Il chiasso. Per esempio se arriva un tir o una macchina della polizia con le sirene accese o magari un camion dei pompieri o un’ambulanza che suona. E se si arrabbia…»
«Distrugge tutto!» gridò lui trionfante. Non ero certo che il suo trasporto per lo yeti fosse un buon segno, ma sapevo che in qualche maniera costituiva una necessità. La figura dello yeti riempiva un vuoto, rendendo a Nicola una parte di fiducia. Nicola era un acrobata, l’esistenza la corda su cui camminava e lo yeti il bilanciere.
«Già» confermai, saziando la sua smania. «Distrugge tutto.» E poi, non so perché, mi vennero le lacrime agli occhi. Mi trattenni. La strada svoltava, un po’ di vegetazione si trovava alla nostra destra e il mare alla nostra sinistra. Mi giunse alle narici un odore buono ma indecifrabile, un misto di terra e sale.
«Però» disse Nicola dopo un breve silenzio (me lo figurai che alzava l’indice della mano destra, uno scrupoloso studente in miniatura) «lo yeti non si arrabbia coi bambini, vero?»
«Vero.» Per fortuna mi uscì una voce ferma. «Lo yeti coi bambini non si arrabbia.»
«Sia maschi che femmine?»
«Sia maschi che femmine.»
«Nemmeno se fanno confusione?»
«No.»
«Nemmeno se urlano o piangono o fanno il verso dei pompieri o della polizia o dell’ambulanza vicino dove sta lui?»
«Nemmeno allora» confermai, e pensai: chiamate un’ambulanza. È tardi. Tardi.
«Mai mai mai?» s’intestardì Nicola.
«Mai mai mai.»
«Perché lui vuole bene ai bambini, vero?» Anche questa domanda rientrava nel copione.
«Esatto. E c’è di più. Non solo lo yeti vuol bene ai bambini, ma li sorveglia e li protegge di continuo, sempre, ogni santo giorno.»
Nicola alle mie spalle sorrise, non ebbi dubbi. Percepii il suo sorriso nell’aria. Durante gli ultimi mesi avevamo sviluppato una forma di comunicazione che trascendeva i sensi, una specie di telepatia che rischiava di spezzarmi i nervi. L’eccessiva tenerezza pesa come un macigno.
«E se è lui a proteggerli…» mi rilanciò la palla Nicola.
«Se è lui a proteggerli nessuno può attaccarli, perché lo yeti è invincibile» conclusi osservando il cielo. Era color indaco, ci galleggiava dentro una mezzaluna tersa e nell’ammirarlo mi sentii perfino in grado di accettare la sciagura dell’esistenza.
Fu allora che Nicola elaborò una domanda in più, una domanda nuova – è sempre così con i figli, non sai mai da quale parte arriverà la sorpresa né che tipo di sorpresa sarà, se buona o cattiva, rassicurante o sconvolgente. I figli, queste sacche d’ignoto, ciò che abbiamo dimenticato dentro di noi e che ci chiama. «È stato lo yeti a prendere la mamma, papà?»
Non ciò che disse, ma la maniera in cui lo disse mi scavò un buco in pancia. Parlò come se avesse infine, dopo mille indugi, trovato il coraggio di pormi l’interrogativo. La bicicletta sbandò ma stavolta non sfiorammo nessuno; raddrizzai la traiettoria un attimo prima di schiantarmi contro un cassonetto dell’immondizia da cui traboccavano buste, sacchi e il brandello di una tutina viola.
«No, non è stato lo yeti a prendere mamma» replicai. «Non è stato lui, Nic.»
«E chi è stato?»
«Non l’ha presa nessuno. La mamma è dovuta andare in un posto lontano. Lo sai già.»
«Non è vero» disse in tono basso e tremendamente saggio, conclusivo, quasi che spettasse a me accettare l’amara realtà. «Perché non mi ha portato con lei? È una bugia.» Non lo domandò, lo affermò.
Il sudore mi si rapprese addosso e la strada si trasformò in un imbuto. Notai di sfuggita, a un paio di metri dal bordo della pista ciclabile, uno di quei limoni di metallo dentro cui ci si mette a vendere bibite. Il limone era chiuso – probabilmente apriva dopo cena – e vederlo finì d’angustiarmi, come se quello stupido guscio serbasse le risposte agli interrogativi di mio figlio ma non intendesse condividerle. Poi affiancammo la pineta; alitava una bruna frescura che sapeva di resina, polvere e vecchie radici. Dopo la pineta scorsi un tratto di spiaggia libera e pensai che l’indomani potevamo recarci lì. La sabbia sembrava pulita.
«Non è una bugia, Nic.» Tacqui. Il tempo corre veloce e i figli crescono, lui stava per compiere sei anni e doveva sapere. Ma non era facile. Spesso la menzogna si rivela la via più semplice, tu la imbocchi e non riesci a fermarti. Ciò che crediamo di comprendere è duro da mandar giù e tendiamo a raccontare falsità cui finiamo per credere, ci aggrappiamo alle nostre stesse menzogne con le unghie, i denti e la lingua. Ma non puoi rifilare frottole a un figlio in eterno. «È solo che certe volte, vedi Nic…» ritentai. «Certe volte la gente ci lascia anche se non sembra giusto. Anche se poi le persone soffrono. Alla mamma è successo. È andata via. Lei non voleva andarsene. Te lo giuro, Nic.»
«Ma non tornerà, giusto?» Di nuovo quel lancinante fatalismo – da quanto me lo nascondeva? E lo nascondeva per evitare che ne soffrissi o perché non ne era consapevole?
Imboccando una via mediana ammisi: «Non so se tornerà, Nic. Temo di no… Ma so che si trova in un bel posto, anche se è un posto lontano… E so che da laggiù ti segue e tifa per te. E so che ti vuole un mondo di bene. E ti aspetta». L’ultima frase suonò macabra alle mie stesse orecchie, ma non me la rimangiai. Mio figlio doveva realizzare un fatto: l’esistenza è un oceano su cui galleggiamo come tappi di sughero. O forse ero io a dover realizzare che lui lo sapeva già.
Nicola rimuginò sulle mie parole. Me le figuravo ruotare nel suo cervello, tracciarvi percorsi di senso più o meno compiuto, sfrigolare, contrarsi e distendersi. «Non l’ha presa lo yeti, allora?» interrogò, rompendo un silenzio nel quale, a dispetto del baccano circostante, udivo il brusio della bicicletta sulla ghiaia.
«No, Nic. Non l’ha presa lo yeti.»
«Peccato» commentò. Non mi toccava più la schiena con le mani e per un secondo temetti che fosse chiuso. Chiuso dentro. Ma dove? scomparso. Invece soggiunse: «Peccato che non l’ha presa lo yeti, papà. Almeno potevo chiedergliela indietro».
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
Letto con molto piacere, storia che pretende di essere letta, che prende per mano il lettore e lo guida in un giardino solo apparentemente tranquillo, fin quando le siepi basse non si fanno più alte e labirintiche e secche… fin quando i rumori passano da lievi ad assordanti, fin quando il profumo non diventa tanfo, fetore. Il romanzo, scritto in prima persona, racconta la storia del protagonista che si trova a dover convivere con un lutto terribile, che cerca di salvare il rapporto con il proprio figlio e al tempo stesso di costruirne con lui uno nuovo, necessario per convivere con il lutto. Racconta della vita che va avanti, per chi resta, con i suoi amori e drammi e prove e misteri, racconta della perdita di una persona cara che ci porta a cambiare il nostro rapporto con noi stessi e con gli altri, che ci costringe a rimodulare, ripianificare, riformulare la nostra vita. Il protagonista del romanzo ci prova ad andare avanti, a convivere, nel provarci si apre a nuove possibilità, nuovi amori. Nella confusione del trauma subìto non è in grado, o rifiuta di vedere, quello che a posteriori apparirà ovvio… il pericolo, il male, la morte, sempre in agguato dietro l’angolo. Forse perché la tristezza, quando ci arriva addosso come un tir carico di massi, ci porta a rifiutare ulteriori mali, anche quelli evidenti, ci satura; ma il tempo scorre e presenta continuamente i suoi conti, sempre nuovi, a volte positivi, a volte terribili… I dialoghi sono vivaci, a tratti realistici a tratti molto letterari, i personaggi dialogano tra loro di storie e di scrittura, ( Stevenson ), sono ben caratterizzati e nella loro ricchezza di sfaccettature, di possibilità, sono molto umani. La scrittura del romanzo è ricca, piacevole, ricercata e allo stesso tempo chiara. Ogni parola pare esser stata scelta con cura per essere inserita proprio là dove si trova. Metafore e similitudini a volte vengono scagliate sul lettore come lame affilate, a volte vengono soffiate come petali di seta.
Recensioni
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

«Prima c’era… ora non c’è più». La scomparsa sembra essere diventata la costante della vita di Riccardo, il padre, e di Nicola, il figlio di quasi sei anni, da quando la loro Lisa è stata colta nel sonno da un improvviso infarto. Passano i mesi e Riccardo continua a sognare la moglie, che gli appare in forme sempre più inquietanti. Decide, quindi, di passare l’estate con il piccolo Nicola a Colombaia, un paese sul mare a prima vista tranquillo. Quando sparisce nel nulla un’animatrice della spiaggia, riemergono altri casi analoghi avvenuti in passato nella stessa zona, uno dei quali riguarda proprio un bambino. I cattivi presagi, oltre che negli incubi, si accumulano anche nella realtà e spetta a Riccardo difendere suo figlio dal buio che li circonda.
Cosa c’entra lo yeti con tutto ciò? Nicola nutre una grande passione per l’uomo delle nevi e ne è affascinato al punto da scrivergli una lettera. Di solito ne parla solo con il padre, ma all’improvviso si mette a discuterne in continuazione con il misterioso vicino di casa, l’anziano signor Inverno. Chi è costui? È buono o cattivo, come mai va d’accordo solo con Nicola? Riccardo, anche un po’ per gelosia, si interroga e teme lo strano legame tra il vecchio e il suo bambino.
È molto difficile, per Riccardo, affrontare un evento così traumatico come una morte improvvisa, soprattutto dovendo cercare le parole giuste per spiegarlo a chi è troppo piccolo per capire fino in fondo. Eppure questo dramma passa quasi in secondo piano rispetto al timore costante di un padre per la sorte del figlio, minacciato da forze oscure che incombono senza mostrare il loro volto. Merito di Enrico Macioci, già autore per Mondadori di Breve storia del talento, che ci tiene sulla corda fino alla fine, in equilibrio tra l’inquietudine e la tensione dei libri di genere (viene in mente uno Stephen King a tinte meno forti) e l’esplorazione più “letteraria” dei legami famigliari. Riccardo si trova a dover ricostruire la propria vita, con tutti i sensi di colpa verso il fantasma della moglie, e allo stesso tempo a educare alla vita Nicola. Entrambe le imprese incontrano degli ostacoli. Provare di nuovo interesse per un’altra donna ha molto a che vedere con il superamento del lutto, così come, da bambini, fare nuove amicizie con i coetanei rappresenta un passo importante per la crescita. Ma non ci si limita solo alla dimensione personale, perché c’è un mistero molto più grande di un caso di cronaca nera in gioco. Alla fine Riccardo è atteso da un regolamento di conti con la radice stessa dei mali che pervadono il nostro mondo, in una prospettiva quasi metafisica, una sfida angosciante ma ineludibile in cui investire tutte le proprie forze.
Dopo l’ultima pagina, forse, anche noi torneremo a chiederci, con curiosità infantile, se in fondo lo yeti in questo libro sia buono o cattivo. E la domanda (proprio come la risposta) acquisterà un altro significato.
Recensione di Damiano Latella.
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri