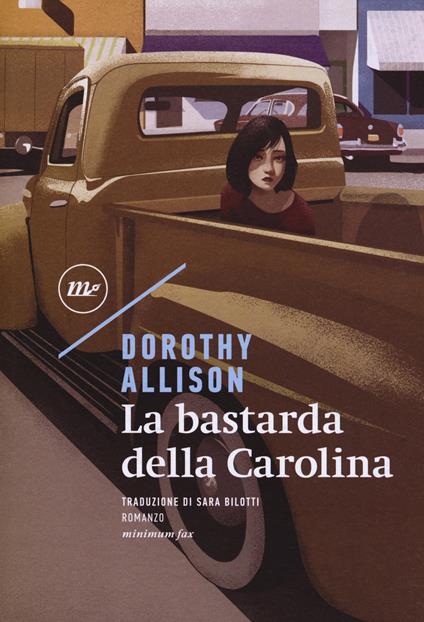L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
La bastarda della Carolina
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti













Tutti i formati ed edizioni

Anno edizione: 2018

Anno edizione: 2018
Ambientato negli anni Cinquanta, ricco di riferimenti autobiografici, il romanzo di Dorothy Allison racconta con un'intensità senza precedenti un mondo crudele e amorevole al contempo, nel quale la brutalità maschile e la resilienza delle donne, il desiderio di rivolta e la forza dei legami familiari coesistono in un intrico indissolubile.
Ruth Anne Boatwright, per tutti Bone, dal padre ha ereditato solamente un certificato di nascita che la dichiara bastarda. A sorreggerla – in una cittadina del South Carolina segnata dalla povertà e dal degrado e in una famiglia nella quale amore, rabbia e prevaricazione fanno parte di un unico coacervo di sentimenti spesso incontrollati – è il disperato e dolcissimo rapporto che la lega alla madre, e che neanche le violenze subite dal patrigno riusciranno a spezzare. La scrittura cristallina e di inarrivabile durezza, la profondità dello sguardo gettato sull'adolescenza, il ritratto dall'interno dei «White Trash» e di un Sud quasi senza riscatto hanno fatto gridare la critica al capolavoro e hanno indotto a paragoni con classici quali "Il buio oltre la siepe" e "Il giovane Holden". In un profilo appassionato pubblicato sul "New Yorker", David Cantwell ha scritto, tra l'altro: «La storia di Bone è piena di rabbia, ma anche di generosità e di amore. Bone ha saputo descrivere senza reticenze tutte le cose mostruose che i genitori le hanno riservato, senza per questo cedere alla tentazione di rappresentarli come mostri. Grazie a questa scelta la protagonista è diventata una scrittrice, ed è stata in grado di presentare se stessa non come trash, ma come un'eroina fragile, complessa e onesta, al centro di una magnifica storia».
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
Un libro molto molto doloroso. Una lettura importante. Bellissimo.
Un romanzo che racconta la violenza e lo fa in un modo che non lascia indifferenti. L'ho trovato peró dispersivo in molti punti. Personalmente avrei dato una sforbiciata qui e lì.
Ho letto questo libro su consiglio di un amico. È sicuramente scritto molto bene e i personaggi sono ben caratterizzati. Ma non mi sembra un libro completo. La violenza che lo caratterizza non determina nessun movimento nella protagonista che continua a provare rabbia dall'inizio alla fine del romanzo. Come viene elaborato il trauma se viene elaborato? Sembra quasi un reportage romanzato più che un romanzo vero e proprio.
Recensioni
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

Allison, il coraggio di sopravvivere nelle ostilità
Dorothy Allison è una di quelle scrittrici che non ti accompagna gradatamente all’interno di una storia: ti getta all’improvviso in un luogo e ti sommerge con l’intensità che si respira nell’aria. Un luogo non è semplicemente uno spazio fisico, una cittadina del South Carolina all’inizio degli anni ’50: un luogo è un sentimento, un significato che evoca delle emozioni. “Place is emotion” (Dorothy Allison, Place, in The Writers Notebook: Craft Essays from Tin House, Tin House Books, 2009).
Le emozioni sono quelle di una bambina di nome Ruth Anne Boatwright, la narratrice del romanzo La bastarda della Carolina (400 pagine, 18 euro), pubblicato dalla casa editrice Minimum Fax nella meravigliosa traduzione ad opera di Sara Bilotti: il lettore assiste nelle prime pagine alla sua nascita improvvisa e maldestra, quando la madre è scaraventata fuori dall’auto a seguito di un incidente. A questa prima, violenta espulsione segue la sua fuoriuscita dal corpo materno. La madre non ha il tempo per scegliere un nome e dopo tre giorni di sonno forzato in ospedale tutto è già stato deciso: il nome, il soprannome e lo stato di bastarda. Sua figlia si chiamerà Ruth per zia Ruth, e Anne come la madre, mentre il suo soprannome sarà per sempre Bone (“ossicino”), perché così la chiamò zio Earle poco dopo averla vista. La dichiarazione di illegittimità è l’atto finale di una serie di goffi tentativi con cui le zie e la nonna cercano di mascherare il fatto di aver dimenticato il cognome del padre, cacciato dalla città “perché aveva fatto casini con la figlia”.
La madre non accetta l’epiteto di “bastarda” per la propria figlia: sa bene che questa infamante etichetta è destinata a marchiarla come una outsider, una figura ai margini della working-class americana, che già annaspa per sopravvivere in un ambiente ostile, al limite della sopravvivenza. Decisa a non accettare un certificato di nascita che reputa ingiusto, poiché redatto in sua assenza, si presenta diverse volte in municipio per chiedere la revisione di un atto che rappresenta un monito e una punizione al tempo stesso: Bone incarna le conseguenze di una non conformità al modello della famiglia tradizionale, e la sua identità si delinea per opposizione ai ruoli sociali rigidamente imposti da un sistema patriarcale.
In parte autobiografico in parte fiction, come rivela l’autrice nella postfazione, il romanzo racconta l’infanzia di Bone, segnata dalle violenze subite dal patrigno e dall’oppressione di un contesto sociale dove la paura, l’ignoranza e la vergogna impediscono la denuncia degli orrori compiuti tra le mura domestiche. Il ritmo incalza e l’interesse di chi legge è continuamente sollecitato da un principio basilare: la prevedibilità del male. Il rapporto con “papà Glen” non può che peggiorare e pagina dopo pagina aumenta il timore che le percosse si tramutino in carezze disgustose. Ingiustizie di ruoli. Nel mondo descritto da Dorothy Allison gli uomini sono trattati come ragazzini cresciuti, “adolescenti turbolenti dei cui capricci bisognava più ridere che preoccuparsi”; ragazzini a cui è permesso fare tutto perché anche la loro violenza trova comprensione e questo divertimento diminuisce la gravità del male inflitto. Le donne invecchiano in fretta a causa del troppo lavoro, abbandonano la scuola e iniziano a mettere al mondo figli al di fuori del matrimonio, dispensando cure a destra a manca, “sembrava fossero nate solo per fare le madri, le balie, le cameriere”… agli uomini.
La povertà beffarda dilaga senza tregua: le opportunità di lavoro sono scarse e poco retribuite, i figli reclamano cibo a gran voce e i creditori bussano alla porta per riscuotere. “Nel nostro paese c’era il mito dei poveri” afferma l’autrice, ovvero l’immagine di un povero buono, straccione ma gran lavoratore, insomma il tentativo di idealizzare l’immobilità dello status quo: uscire dalla propria condizione è rischioso e fallimentare, meglio illudersi di vivere bene. Bone non crede a sua madre quando le dice che i Boatwright non sono persone cattive: sa bene che quella definizione di povero sta stretta alla sua famiglia, è consapevole di essere disprezzata. Le donne della sua famiglia sono arrabbiate, gridano e sbraitano a mariti che non ascoltano; i bambini sono maleducati, sporchi e malnutriti; gli uomini raramente sono sobri e vedono nell’alcool e nella violenza il simbolo di una virilità irrinunciabile, anche a costo di perdere il lavoro.
Rimane la rabbia, un calore cieco in fondo agli occhi che “voleva uscire e incendiare tutto, tutte le cose che loro possedevano e noi non potevamo avere, tutto ciò che li faceva sentire migliori di noi”. È la rabbia di essere additata come “white trash” (spazzatura bianca), di provare vergogna per le molestie subite, di dover lottare per continuare a vivere. È sempre la rabbia che conduce alla scrittura, una sorta di processo irreversibile che svela il carattere salvifico di quella veemenza che non si lascia reprimere, di quelle parole scritte con furia e avidità di raccontare l’umiliazione, la paura, il disprezzo per se stessa a causa delle violenze subite. “Dovevo vederci chiaro, e l’ho fatto scrivendo”: così Dorothy Allison descrive il proprio processo creativo e il suo personale rapporto con la scrittura, che considera uno strumento estremamente efficace per incentivare il cambiamento, per smascherare una verità scandalosa grazie alla finzione della narrativa e al coraggio di rimanere fedeli a se stessi.
Autrice di culto in America, l’opera di Dorothy Allison è ascritta alla tradizione lirica sudista a fianco di Carson McCullers, William Faulkner, Flannery O’Connor e ad alcune scrittrici del movimento femminista di terza ondata, tra cui Toni Morrison, Audre Lord e Grace Paley. La critica ha evidenziato l’innovazione straordinaria che l’autrice inserisce all’interno di questa tradizione: l’associazione unica tra la drammaticità della sua condizione e un senso dell’umorismo irriverente, grottesco e indispensabile per la sopravvivenza. “C’era solo un modo per vincere contro il dolore e l’odio. Mamma imparò a ridere prima che gli altri ridessero di lei”. Il linguaggio è diretto, sporco, come immondo è l’ambiente che circonda l’infanzia di Bone, dove la sporcizia è il simbolo del senso di colpa che perseguita la vittima di un abuso. I personaggi sono solidi e dai dialoghi traspare ogni dettaglio del loro carattere aspro e duro.
La voce finale raschia la superficie del testo, è vibrante, arrabbiata, sfacciatamente ironica: è la voce di una che ce l’ha fatta, che è riuscita ad uscire, che non ha accettato o internalizzato le norme sociali di un contesto degradante. L’atto stesso di raccontare è una forma di riappropriazione dell’identità e la definitiva accettazione dell’essere sopravvissuta all’orrore. Forse, amaramente, è proprio per questo che la lettura di questo romanzo venne vietata nelle scuole poco dopo la sua pubblicazione: non è infatti la brutalità della violenza descritta a renderlo un libro pericoloso, ma la possibile rivolta della vittima e la sua trionfante vittoria. “C’è infatti da aspettarsi molto di più dalla rivolta delle vittime che dalla caricatura dei loro carnefici”. (Roland Barthes).
Recensione di Silvia Gasparoni
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri