L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Il libro delle rime
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti


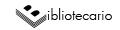


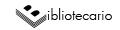

Tutti i formati ed edizioni
Prima edizione completa delle poesie di Franco Sacchetti (1332-1400) con testo critico e commenti ad ogni poema.

SCOLARI, ANTONIO (A CURA DI), Il romanzo di Tristano
SACCHETTI, FRANCO, Il libro delle rime
LANZA, ANTONIO (A CURA DI) / TRONCARELLI, MARCELLINA (A CURA DI), Pellegrini scrittori. Viaggiatori toscani del Trecento in Terrasanta
recensione di Meliga, W., L'Indice 1991, n. 6
La produzione qui in esame si inscrive nell'arco di un secolo - il Trecento - in cui la critica ha spesso individuato l'epoca dell'esaurimento delle strutture ideologiche universalistiche del medioevo, attraverso una pluralità anche contraddittoria di esperienze. I testi vanno dagli anni a cavallo fra la fine del Due e l'inizio del Trecento, per il "Tristano", al 1400, anno dell'ultima canzone e della morte di Franco Sacchetti. È suggestivo osservare come si cominci a discorrere di fuoriuscita letteraria dal medioevo proprio con un mito che il medioevo più vero, quello di Francia, ha segnato con intensità. Lasciamo pure andare i perduti archetipi celtici dei secoli alti: Tristano conta a partire dalla seconda metà del secolo XII, quando i poemi dei normanni Béroul e Thomas (e gli altri perduti, tra i quali anche uno dei 'novelist' più famosi, Chrétien de Troyes) ne stabiliscono la storia nei termini che affascineranno lettori e rielaboratori di mezza Europa. Dall'inizio del Duecento, nelle citazioni che ne fanno i poeti siciliani, data la sua ricezione italiana, mentre è solo alle soglie del secolo successiva che appare il primo volgarizzamento. Il clima è però cambiato, già dalla fonte - il "Roman de Tristan* in prosa - che accoglie Tristano nella compagnia arturiana e ne accentua i tratti "cavallereschi" a scapito dell'intensa e interiorizzata versione "cortese" di Thomas (a cui si rifà in sostanza ancora Wagner), con una narrazione caratterizzata da espansione ciclica e da minor impegno strutturale. Da parte italiana la colorazione "urbana" di certi episodi non fa che confermare l'importanza della presenza borghese e mercantile nella diffusione e rielaborazione dei materiali romanzeschi (ed epici) francesi, e colloca il "Tristano" in una categoria di narrativa di appendice, adatta a un pubblico medio e che meriterà il giudizio di sufficienza di Petrarca. Questi caratteri sono ben sottolineati dal curatore Scolari (che dà una buona edizione del testo con utili note).
Letteratura di evasione per mercanti e borghigiani, ma anche letteratura di informazione: le relazioni di viaggio in Terrasanta hanno una lunga tradizione, che risale agli 'itinera' del Basso Impero, ma si diffondono specialmente dalla metà del Trecento, grazie a una mobilità accresciuta dalla crescita economica e dalla normalizzazione dei rapporti fra Occidente e mondo arabo dopo la caduta del regno latino di Gerusalemme. Gli autori delle narrazioni sono - secondo l'espressione di Vittore Branca - i protagonisti del nostro Trecento: cittadini, spesso inseriti nell'attività commerciale-finanziaria o nell'amministrazione civile, e frati; i testi offrono un resoconto ricco di informazioni, non soltanto devote, e in essi si riversa un'esperienza intensamente partecipata ma anche scrupolosamente registrata. Proprio qui mi sembra stia l'interesse, e la relativa novità, delle relazioni, ben più che nella ricerca di pregi letterari francamente saltuari. Il confronto da istituire è quello con la letteratura dei 'mirabilia' orientali (della quale partecipa anche Marco Polo), che tanta parte occupa della geografia medievale e rispetto alla quale i resoconti dei pellegrini trecenteschi offrono quasi nessun esotismo a fronte di una franca apertura alla realtà. Né è da trascurare una scrittura in parte nuova, aperta e svincolata dai vecchi generi, che prelude a tradizioni future di "ragionamenti" di viaggio.
Di questo secolo borghese e devozionale Sacchetti è in qualche modo un simbolo. Tipico "minore", la sua produzione novellistica e poetica è naturalmente rapportabile a quella dei due grandi dioscuri del Trecento, Petrarca e Boccaccio. In poesia però la lezione petrarchesca può agire solo dall'esterno, verso il "libro di rime", mentre la sostanza è quella di un eclettismo cortese-comico-didattico, dove ancora la lezione più interessante, in tanto epigonismo, è una disposizione borghesemente verista, non necessariamente limitata al settore più autobiografico e "impegnato".
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri


