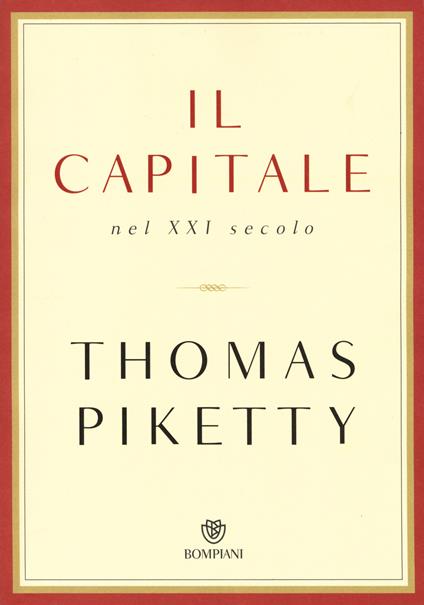L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Il capitale nel XXI secolo
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti
Altre offerte vendute e spedite dai nostri venditori



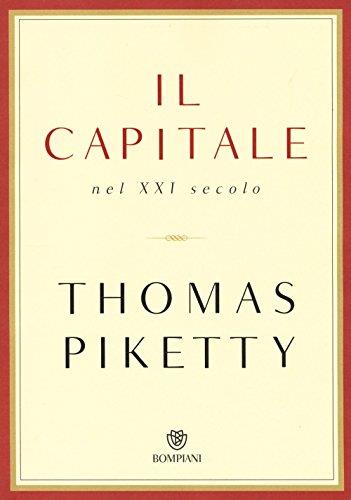











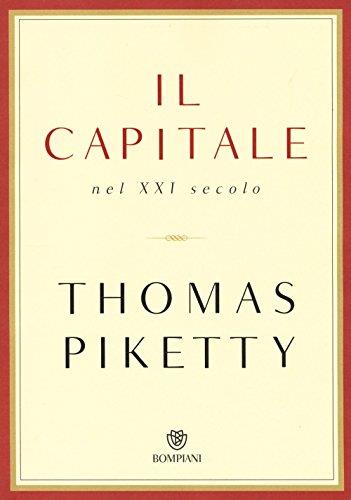









Tutti i formati ed edizioni
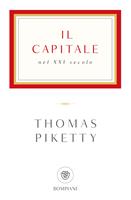
Anno edizione: 2016

Anno edizione: 2018
Promo attive (0)
Scelto da IBS per la Libreria ideale perché una nuova, contemporanea riflessione sul capitale (concentrazione della ricchezza, diffusione della povertà, disuguaglianza dei redditi) è importante. Seppur non una lettura per tutti, certamente un libro da avere.
Quali sono le grandi dinamiche che guidano l'accumulo e la distribuzione del capitale? Domande sull'evoluzione a lungo termine dell'ineguaglianza, sulla concentrazione della ricchezza e sulle prospettive della crescita economica sono al cuore dell'economia politica. Ma è difficile trovare risposte soddisfacenti, per mancanza di dati adeguati e di chiare teorie guida. In "Il capitale nel XXI secolo", Thomas Piketty analizza una raccolta unica di dati da venti paesi, risalendo fino al XVIII secolo, per scoprire i percorsi che hanno condotto alla realtà socioeconomica di oggi. I suoi risultati trasformeranno il dibattito e detteranno l'agenda per le prossime generazioni sul tema della ricchezza e dell'ineguaglianza. Piketty mostra come la moderna crescita economica e la diffusione del sapere ci abbiano permesso di evitare le disuguaglianze su scala apocalittica secondo le profezie di Karl Marx. Ma non abbiamo modificato le strutture profonde del capitale e dell'ineguaglianza così come si poteva pensare negli ottimisti decenni seguiti alla seconda guerra mondiale. Il motore principale dell'ineguaglianza, la tendenza a tornare sul capitale per gonfiare l'indice di crescita economica, minaccia oggi di generare disuguaglianze tali da esasperare il malcontento e minare i valori democratici. Ma le linee di condotta economica non sono atti divini. In passato, azioni politiche hanno arginato pericolose disuguaglianze, afferma Piketty, e lo possono fare ancora.
Venditore:

Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
Il pregio di questo libro, al di la delle tesi esposte, è la semplicità espositiva che permette anche ai non addetti ai lavori di comprenderne il contenuto. Il difetto è il rovescio, cioè proprio la chiarezza espositiva lo rende molto lungo e a volte ripetitivo (900 pagine!) . T. Piketty è l'economista di una nuova politica economica che affonda le sue radici in studi di altri autori anche lontani nel tempo e che, si auspica, i politici attuali e quelli che si battono nella competizione elettorale PV tengano seriamente in considerazione.
Libro chiaro, facile da capire, ma molto impegnativo (circa 1000 pagine). molto incentrato sull'analisi storica per arrivare a fare interessanti considerazioni sul presente, sul perchè di alcune dinamiche economiche importanti e con qualche timida e ponderata proiezione verso il futuro. inutile comprarlo se non si intende dedicarci il tempo che merita. pessima la rilegatura, scelta della carta e copertina soft. un libro così meritava ben altra rilegatura con copertina rigida.
L'autore di questo saggio, grazie ad una analisi dettagliata e ad una raccolta di dati, unica, da venti paesi, dal XVIII secolo ad oggi, ci guida sui percorsi che ci hanno condotto alla nostra realtà socioeconomica. I risultati di questo studio influenzeranno il futuro dibattito sul tema della ricchezza e dell'ineguaglianza.
Recensioni
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.


Riprendendo le analisi di Marx, Thomas Piketty ha scritto questo monumentale saggio, che ha scosso gli Stati Uniti ed è destinato a entrare nel cuore del dibattito europeo. La tesi è semplice: il Capitale si concentra via via nelle mani di pochissimi e cresce in una percentuale sempre maggiore rispetto alla crescita del reddito generale. Una situazione in cui non si vedono tendenze contrastanti e che è destinata a generare conflitti sociali e politici sempre più approfonditi. L'unico argine a questa situazione non è e non può essere, come detto, una tendenza interna al capitalismo, ma una decisione extraecomica, politica. Ma la politica ne è ancora capace?
L'articolo è stato aggiunto al carrello
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da IBS, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.ibs.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafetyibs@feltrinelli.it
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
Siamo spiacenti si è verificato un errore imprevisto, la preghiamo di riprovare.
Verrai avvisato via email sulle novità di Nome Autore