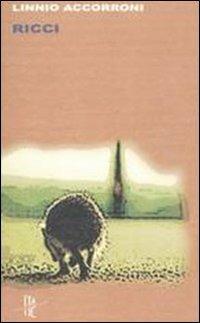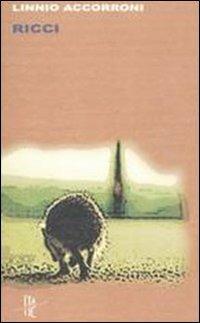C'è un clima iperrealistico in Ricci di Linnio Accorroni, libro di poche pagine ma molto intenso e dalla forma inusuale, anche tipografica, che parla di malattia e di presagi di morte, come è iperrealistica ed esistenzialistica quella zona d'ombra nel corso della quale i corpi fanno un combattimento aperto contro il declino, laddove si gioca forse il punto più alto, il climax di una vita intera minacciata dall'idea dell'estinzione. Quando quel momento arriva, irrompe in quella che l'autore chiama "la cosa giornaliera", tutto cambia: il vecchio genitore quasi ottantenne, ammalato di tumore al retto, defeca di continuo, sente in questo nuovo aspetto corporale il senso della fine: "Adesso la mia cacca s'è trasformata e degradata: emana una puzza che sa di fetido, di marcio, di fradicio, di corrotto, di qualcosa che si sta rompendo o si è già rotto. Puzza d'uova marce e di cadavere d'animale insieme. Una puzza che puzza come può puzzare solo la morte". La merda diventa una metafora che reitera in un libro anche molto "corporale", dove l'avventura dei sensi, quella del dolore, diventa forma nella sua urgenza più necessaria. Così in questa narrazione, in questo "quaderno del dolore", come lo definisce con esattezza Adelelmo Ruggieri nella sua affettuosa bandella di presentazione, costruita principalmente su un intreccio di voci, quelle di un figlio e di un padre, voci che quasi mai diventano dialogo, ma finalmente si riguardano, la cui unica pecca è forse quella di una parentela di lingua, una volta aperta la ferita, fatta l'anamnesi, due vite che sono corse per anni parallele nel rapporto ereditario adesso sono costrette a cambiare punto di vista scoprendosi come fosse la prima volta. Allora il figlio, un professore che è stato anche un militante politico e un intellettuale scettico, disincantato, mette in moto la sua strategia di avvicinamento. "Tutto improntato a sguardi e silenzi, a sfioramenti e cortesie" dice in una notazione. Ne scaturisce una tramatura di microstorie dal quotidiano che però ambiscono, per la loro forza evocativa, a illuminare la condizione umana tout court, e ciascuna di loro è una porzione del mosaico che mentalmente il lettore, e sulla carta l'autore, ricostruiscono alla fine del libro mettendo insieme tutti i tasselli di una memoria eterogenea, di cui lo scrittore mette in salvo solo alcuni passaggi nevralgici, solo pezzi di "nastri" di ricordo, come un po' accade in un libro nematicamente affine di un grande scrittore americano, Patrimonio di Philip Roth. Pieno di pietas, il romanzo di Accorroni non scade però mai nel pietismo, che in narrazioni di tale genere è sempre in agguato, e lo scrittore è bravo non solo a schivare queste trappole molto frequentate dalla narrativa corrente in cerca di lettori da far commuovere, che anzi sollecita artatamente l'intenerimento, ma cinicamente, con un cinismo che è scelta di stile, mette in campo scene a volte di una comicità esilarante, come quella del tipo colto da infarto mentre comincia a nevicare, il quale pensa così che la neve, che lui adora, scende dal cielo mentre sta morendo, o pensa di morire; o come gli aforismi sul tumore nei pensieri del vecchio malato (che anche quando si lamenta non concede niente al melodrammatico: "Perché a me e non a quel vicino di casa puttaniere e giocatore, che invece se la continua a godere alla grande?"), che fanno ricordare il protagonista di un film evocato dal figlio in un passo, Le invasioni barbariche, un vero inno alla laicità della vita. Scritto con una lingua abilmente elaborata e colta, dove riverberano, echeggiano in un magma complesso diversi debiti letterari, che troviamo anche nelle tante epigrafi iniziali, quello che più colpisce è l'effetto di verità che Accorroni insegue e raggiunge, anche attraverso brutali e sgradevoli descrizioni ambientali e corporee della malattia, nella nuda essenza di un'esperienza comune ma sempre molto estrema. Ma cosa c'entrano i Ricci, che danno il titolo a questa narrazione? È il cognome dei due maschi della famiglia? No, i ricci sono alcune piccoli animali del bestiario che l'autore dissemina nel libro come contesto ( li chiama "crimini di pace", numerati come reperti), semmai sono parte della famiglia terrestre e cioè di una natura altra circostante e a molti invisibile, sovrastata dai rumori di sottofondo e dal mondo virtuale e tecnologico: è il formicaio che il tagliaerba ha spazzato via, che al figlio ricorda un terremoto a Messina o Lisbona, le ranocchie spiaccicate sulla strada, il ramarro "schiacciato per terra e il suo verde smeraldo luminosissimo risalta splendidamente", l'istrice o i mosconi che in pochi giorni imploderanno, la talpa morta lungo una strada a lungo scorrimento proprio come i ricci, che "per condizione ontologica, per costume fisiologico, il cielo lo scoprono solo da morti". Angelo Ferracuti
Leggi di più
Leggi di meno