L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Le ragioni del dolore. Etnopsichiatria della depressione
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti




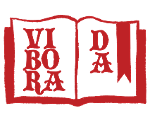



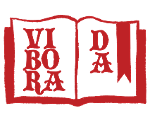
Tutti i formati ed edizioni
Depressione, panico, ansia, fatica cronica: si tratta di malattie in diffusione epidemica, o piuttosto dell'epidemia di determinate diagnosi e prescrizioni? Di un fenomeno davvero inedito, o di nuovi nomi dati a sofferenze antiche? L'approccio etnopsichiatrico rende oggi finalmente possibile un esame a tutto campo (storico e geografico) della questione. Coppo percorre le tappe cruciali della depressione in Occidente, dalla figurazione della malinconia nella Grecia antica alla costruzione della moderna nosografia, indugiando su momenti e connessioni interessanti, come la casuale scoperta dei primi farmaci antidepressivi e il loro ruolo nella definizione psichiatrica del disturbo.
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
Stringato e densissimo, un libro ricchissimo di cultura e di densità su come siamo fatti e di cosa siamo fatti. Fa riflettere moltissimo. Consigliato a chi ama questa branca del sapere.
Recensioni
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

Un libro sulla depressione sulla sua storia sulla storia delle sue cure e sugli approcci terapeutici in rapporto alle diverse culture uno studio etnopsichiatrico sulla melanconia e sulla malattia depressiva. Il consiglio di Coppo è che la medicina occidentale cerchi di evitare la deculturazione e la decontestualizzazione della sofferenza mentale in rapporto all'ambiente culturale in cui si sviluppa. La colonizzazione dell'Africa a opera dei paesi occidentali ha decostruito la cultura dominante dei popoli che venivano colonizzati senza apportarvi necessariamente un progresso tecnico e scientifico significativo di cui quelle culture potessero giovarsi. Ne consegue che non è possibile (e forse non è etico) applicare indiscriminatamente a tutte le civiltà almeno per quanto riguarda la malattia mentale i metodi terapeutici che noi occidentali usiamo nella nostra pratica clinica.
Ne deriva che l'etnopsichiatria più avanzata è oggi in grado di prendere sul serio certi saperi specifici della sua cultura senza sentirsi minacciata né umiliata e senza complessi di inferiorità. Come giustamente scrive Bibeau (1981): Il progetto comparativo transculturale non è possibile che a condizione di restituire in un primo tempo il senso originario che ogni cultura assegna all'amore alla depressione e a ogni elemento della vita. Se non siamo autorizzati a imporre dall'esterno i nostri propri valori categorie e idee l'unica soluzione che ci rimane è quella di penetrare in una cultura specifica e render conto dal punto di vista originale di che idea questa cultura si fa dei fenomeni che ho appena indicato. L'impresa transculturale non può riposare in definitiva che sulla base di numerosi lavori intraculturali sistematici e completi.
è dunque diverso il senso della sofferenza umana che nel mondo occidentale può entrare nella categoria di malattia depressiva. In altre culture può essere inserita in altri percorsi e pertanto attivare altre pratiche destinate alla sua terapia. Un esempio straordinario di sofferenza depressiva collegata alla separazione e alla morte è dato dalle osservazioni antropologiche ed etnopsichiatriche sul modo in cui culture diverse reagiscono alla caducità della vita alle separazioni e alla morte. Queste pratiche sembrano tutte tese a ridurre il rischio che l'oggetto amato che se ne va trascini con sé il soggetto così da rendergli impossibile l'elaborazione del lutto portandolo alla depressione. Il pensiero etnopsichiatrico e antropologico è qui incredibilmente vicino a quello di Freud che in Lutto e melanconia del 1915 sottolinea la differenza tra il lutto in cui parti dell'io identificate con l'oggetto perduto possono essere recuperate e la melanconia in cui questa operazione fallisce e parti dell'io del soggetto si perdono con l'oggetto scomparso.
L'autore presenta numerosi esempi bellissimi e commoventi di come alcune culture affrontano la separazione la morte e il lutto. Accompagnare chi muore nel trapasso aiuta chi resta a elaborare il lutto dando alla morte stessa un significato naturale e positivo. Nel racconto di Thomas relativo all'etnia Birifor dell'Alto Volta (oggi Burkina Faso) è evidente come il ruolo fondamentale nell'accompagnare il malato alla morte sia assegnato alla donna. Questa infatti accoglie il morente fra le sue braccia e aprendo le gambe lo fa come entrare nel suo grembo. Il morente diviene un neonato curato affettuosamente pratica che continua poi dopo la morte con il cadavere e che conferma l'analogia tra la nascita e la morte con l'insostituibile ruolo della donna in questi due atti fondamentali della vita. In altre etnie come ad esempio gli Evé del Togo il coniuge superstite viene forzato anche brutalmente ad accettare la realtà della morte operazione questa tesa ad annullare l'illusione di vivere ancora nell'intimità con la persona scomparsa. Da queste descrizioni appare chiaro come il lavoro nel lutto serva al gruppo a dare un senso autoregolativo all'interno del suo stesso tessuto sociale.
L'etnopsichiatria l'etnopsicologia e l'antropologia relativamente a processi che riguardano la separazione e il lutto sembrano consapevoli di alcuni concetti bioniani come quelli di contenitore-contenuto o di concetti come quello di io-pelle di Anzieu e di Bick. Tali involucri proteggono un nucleo vitale originario che non può uscire da questo involucro pena la perdita di identità. Nella loro idea c'è il concetto di anima come addensamento gelatinoso informe sempre in cerca di un contenitore. E l'abilità degli stregoni o sciamani sta nel catturare l'anima nel momento del trapasso e impedirle di riprendere il suo posto. La persona disanimata diviene allora sofferente se non aiutata. Come dissanguata presenta tristezza debolezza inerzia che può condurre a morte proprio come alcuni pazienti gravi che soffrono di depressione. Anche in queste situazioni l'autore presenta casi di estremo interesse antropologico e psicoanalitico.
è significativo che tra i mezzi terapeutici più comuni ed efficaci che il guaritore africano utilizza troviamo suggerimenti di riti e sacrifici rivolti agli antenati come se l'azione terapeutica fosse concentrata sul recupero del passato e i riti stessi permettessero al paziente di storicizzarlo. è azzardato pensare al processo analitico che ha i suoi riti che impone i suoi sacrifici e che attraverso la ricostruzione permette la storicizzazione del passato più arcaico inconscio del paziente?
Tutti gli esempi riportati utilizzano il corpo o il comportamento o il linguaggio come conseguenze diverse di esperienze analoghe essenzialmente di natura depressiva. Il fascino di tutte queste culture è di essere in grado attraverso particolari personaggi (sciamani stregoni) di lavorare sul destino sul maleficio sulla sfortuna sulle relazioni senza tuttavia ridurre queste esperienze di sofferenza a vere e proprie malattie. Il dibattito – precisa Coppo – su cosa sia meglio o peggio o più efficace (per esempio la prescrizione di un farmaco o quella di un amuleto) è tutt'ora aperto visto che il problema della valutazione comparativa dei vari saper-fare terapeutici non è stato ancora né sarà forse mai risolto per la diversità e molteplicità delle variabili in gioco.
Certo le questioni che l'autore pone sono tutte da discutere con la mente sgombra da pregiudizi. Rappresentano comunque l'oggetto più specifico dell'etnopsichiatria e sono dirette ad affrontare un complesso problema transculturale. D'altra parte l'etnopsichiatria così come la psicoanalisi parla di trauma del ripetersi di eventi del recupero della memoria di ciò che avvenne nel tempo. Spesso vengono valutati i traumi anche perinatali gravi o minori ma ripetuti nel tempo. Il ripetersi dell'evento traumatico può aprirsi la via alla sindrome depressiva e allora le azioni segrete ripetute misteriose benefiche e malefiche degli stregoni possono facilmente inserirsi in questa dimensione affettiva ed emozionale che noi psicoanalisti non avremmo difficoltà a definire inconscia. Sono d'accordo con quanto precisa Coppo: Prendere sul serio un disturbo prodotto da un atto di stregoneria non vuol dire necessariamente cadere nell'oscurantismo irrazionalistico.
Mauro Mancia
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri


