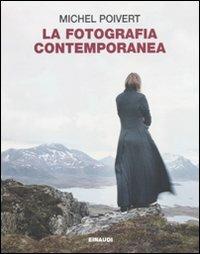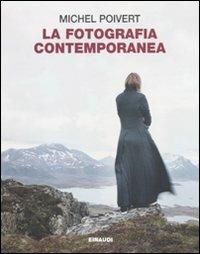C'è qualcosa di inevitabile (e ineluttabile) nel fatto che da un po' di anni a questa parte, chiunque si appresti a pronunciare, scrivere, abbozzare, appuntare, forse perfino pensare, la parola fotografia, associata alle parole "arte contemporanea", senta la necessità di adottare una serie di precauzioni. È una sorta di undicesimo comandamento: vuoi parlare di fotografia? Bene, prima dimmi che cos'è la fotografia, definiscimi il campo semantico del termine, disegnami i confini, precisane, insomma, lo statuto ontologico. Può sembrare curioso, ma è così che stanno le cose. Se uno decide di scrivere, poniamo, un libro su Matisse, o su Dalì, o Brancusi nessuno si aspetta che metta le mani avanti e spenda parole per spiegare che cosa è la pittura, o la scultura. Né, se è per questo, ci si attende simili digressioni anche quando il libro è dedicato a opere più difficili da maneggiare, e che a dire il vero talvolta si gioverebbero di qualche spiegazione: istallazioni, performance, site-specific ecc. Eppure è esattamente questo che avviene quando si inizia a parlare di fotografia contemporanea: ben prima di addentrarsi in descrizioni e interpretazioni, è il concetto a essere sottoposto ad analisi. In altre parole: prima di parlare di fotografie, si parla della Fotografia, quella, appunto, con la effe maiuscola. Aleggia, forse, l'eco della diffidenza con cui qualche decennio fa veniva guardato l'ingresso delle prime fotografie in spazi altrimenti intesi di pertinenza esclusiva degli artisti, musei e gallerie. Ma credo che la ragione vera sia nella difficoltà di costringere le fotografie, tutte le fotografie, entro un unico contenitore, così da poterle considerare, nel loro insieme, una categoria dell'arte contemporanea. Ritratti, reportage, servizi di moda, paesaggi, testimonianze, a colori e in bianco e nero, con tirature numerate e non, con firma o senza firma, elaborazioni digitali e stampe tradizionali, sono tutti prodotti, è vero, dello stesso medium, ma non per questo si può dire condividano un immaginario, abitino un orizzonte estetico comune. Oggetti diversi al punto che già nel 1990 Rosalind Krauss, nel lucido tentativo di dare ragione, almeno parziale, al fenomeno, si era ritrovata nella necessità di ricorrere al termine "il fotografico" anziché "la fotografia". Uno slittamento semantico che voleva in qualche modo segnalare l'affacciarsi di un cospicuo numero di artisti che usavano sì "la fotografia", o meglio la macchina fotografica, ma il cui intento non era "produrre fotografie", bensì opere d'arte. Siamo, insomma, di fronte a un oggetto mutevole i cui contorni si modificano come quelli di una spiaggia sottoposta all'effetto delle maree. Ed è la mutevolezza di questo paesaggio quella che Michel Poivert tenta di imbrigliare. Il procedimento è in apparenza limpido, analitico, cartesiano. Siamo negli anni settanta, è da qui che più o meno la storia comincia. Quando accadono due cose. Da una parte la fotografia-stampa, la classica fotografia, scompare dalle mostre d'arte contemporanea. Dall'altra i reportage, fino a quel momento destinati esclusivamente al mercato editoriale, iniziano a essere trattati come quadri: esposti, commentati, venduti, collezionati. La fotografia, insomma, esce dalla porta (delle gallerie) per rientrare dalla finestra. Probabile abbia contato, in questo, anche il fatto che in quegli stessi anni si andasse verso una progressiva smaterializzazione dell'opera: movimenti come la body art e la land art non possono che affidare alla fotografia non solo la propria memoria, ma la loro stessa esistenza nei circuiti espositivi. Del resto, mica si poteva appendere un fulmine o il Great Salt Lake alle pareti di una galleria
E così le cose cominciano a complicarsi, i distinguo a proliferare, le teorie ad affinarsi e affilarsi. Si inizia a parlare della differenza tra immagine culturale e immagine artistica e soprattutto ci si rende conto che la fotografia non è più, almeno non necessariamente, veicolo e testimonianza di storie narrate altrove. Non le basta più: la fotografia vuole essere il fine della fotografia. Ma allora, se questo è il punto, la domanda da porsi è: a cosa è contemporanea la fotografia contemporanea? E la risposta, per la prima volta, non può più essere: alla società, o all'informazione. La risposta giusta è che la fotografia contemporanea è contemporanea all'arte, si alimenta dello stesso circuito, delle stesse idee e, se vogliamo, della stessa autoreferenzialità. E così, procedendo per progressive approssimazioni, Poivert precisa, dettaglia, circoscrive. Disegna con puntiglio l'impalcatura teorica della questione, la amplia, la articola. È questo il pregio del libro. Ed è questo il limite del libro. Perchè alla fine gli sfugge che la sua è una fatica di Sisifo, trova la casella giusta per un'immagine e subito ne salta fuori un'altra che chiede una nuova pagina dell'album, un nuovo capitolo, una nuova digressione. E alla fine, in tutto questo ragionare, la sensazione è che il grande assente di questa storia, sia proprio l'oggetto-fotografia e lo sguardo, gli sguardi, che ci stanno dietro. Un limite, che solo in parte l'eccellente veste editoriale e la qualità delle immagini riprodotte corregge. L'autore dà la parola a molti soggetti, ma non agli artisti, non alle opere. E se, quasi per sbadataggine, gli capita di farlo, subito prende le distanze. Come quando, parlando di una foto di Natchway, Inferno, dice che "si libera dalle contingenze storiche su cui si fonda qualsiasi testimonianza per ingigantire la rappresentazione fino a farne un'allegoria", o, perplesso, annota che Salgado fa foto "tese unicamente a suscitare emozione e le sue immagini spesso infastidiscono". Ma per fortuna! verrebbe voglia di rispondergli, a noi che piace, più che capire, essere infastiditi dalle immagini. Maria Perosino
Leggi di più
Leggi di meno